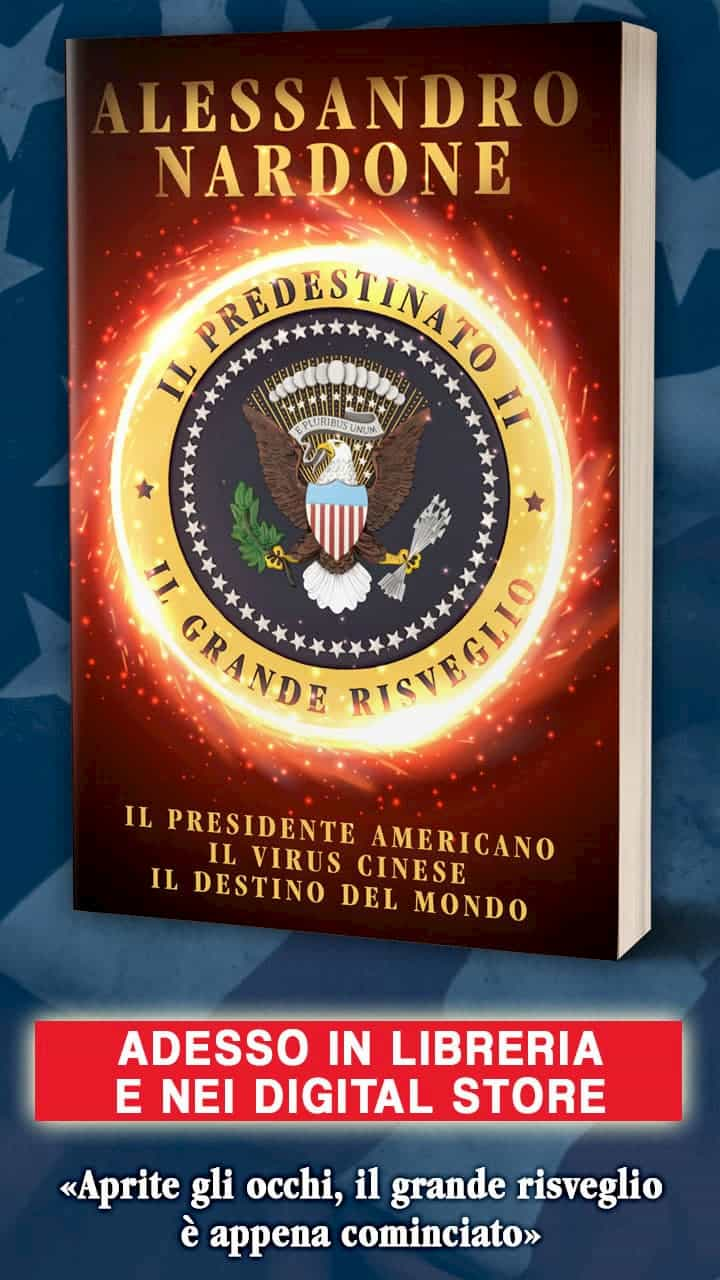Alessandro Nardone per Vanity Fair – Se dieci anni fa Doc Brown ci avesse caricati sulla sua DeLorean per portarci avanti nel tempo fino ai giorni nostri, avremmo faticato non poco ad accettare la realtà odierna. No, non penso all’evoluzione degli smartphone, a Milan e Inter in mano ai cinesi e nemmeno all’ascesa di Donald Trump, ma a quanto sta accadendo in questa pazza campagna referendaria.
Già, perché nel 2006 (per l’esattezza il 25 e il 26 giugno), si celebrò un altro referendum confermativo, ovvero quello sulle riforme costituzionali varate dal governo di centrodestra presieduto da Silvio Berlusconi: più poteri al presidente del consiglio, fine del bicameralismo perfetto e riduzione del numero dei parlamentari. Tre punti che, detti così, ai meno avvezzi alla politica e al diritto costituzionale potranno sembrare ostrogoto ma che, in realtà, significano tre cose molto semplici: che il vincitore delle elezioni avrà la possibilità di governare, che le leggi saranno approvate in tempi infinitamente più rapidi e che a Roma sederanno meno politici.
Al netto della devolution pretesa da Bossi (controbilanciata, però, dalla clausola di interesse nazionale) possiamo tranquillamente affermare che, nella sostanza, la proposta di riforma del 2006 e l’attuale seguano la stessa direzione, segno che i princìpi di cui sopra rappresentano i cambiamenti fisiologicamente necessari a cui sottoporre una Costituzione figlia di un’altra epoca, quantomeno per cominciare a buttare a mare alcune delle zavorre che, di fatto, impediscono all’Italia di tenere il passo di un tempo in cui il concetto di velocità è stato ampiamente superato da quello di immediatezza.
Eppure, gran parte della classe politica che due lustri orsono sosteneva l’importanza vitale delle riforme, oggi è schierata dalla parte di chi sostiene l’intangibilità della Costituzione in molti casi per determinare la tangibilità di Renzi e del suo governo, riesumando il medesimo spettro della «deriva autoritaria» che per un ventennio è stato agitato in faccia all’ex Cav ogni qual volta affermava – a ragione – che uno dei problemi atavici del nostro Paese sia proprio l’ingovernabilità dovuta alla mancanza di poteri del presidente del Consiglio.
Altra similitudine sono gli errori di comunicazione commessi tanto all’epoca da Silvio Berlusconi quanto oggi da Matteo Renzi che, ironia della sorte, cominciano entrambi con la lettera D: devoluzione e dimissioni. Infatti, così come il centrodestra lasciò che l’intero pacchetto di riforme prendesse il nome dell’unica veramente voluta dalla Lega, Renzi ha annunciato le sue dimissioni in caso di sconfitta del Sì: due assist degni del miglior Totti ai sostenitori del No, che nel 2006 poterono avvalersi del pericolo secessionista e, oggi, hanno gioco facile nell’ingrossare le loro fila attorno al messaggio che ogni No sia una picconata a Renzi e al suo governo.
Tuttavia, il nocciolo della questione non è tanto se Tizio avversi le riforme per autentica convinzione e Caio per mero calcolo politico, ma che spesso e volentieri luoghi comuni come «le riforme non si possono fare a colpi di maggioranza» altro non sono che il pretesto di chi sta all’opposizione per non farle mai. Almeno fino a quando non tornerà al governo.