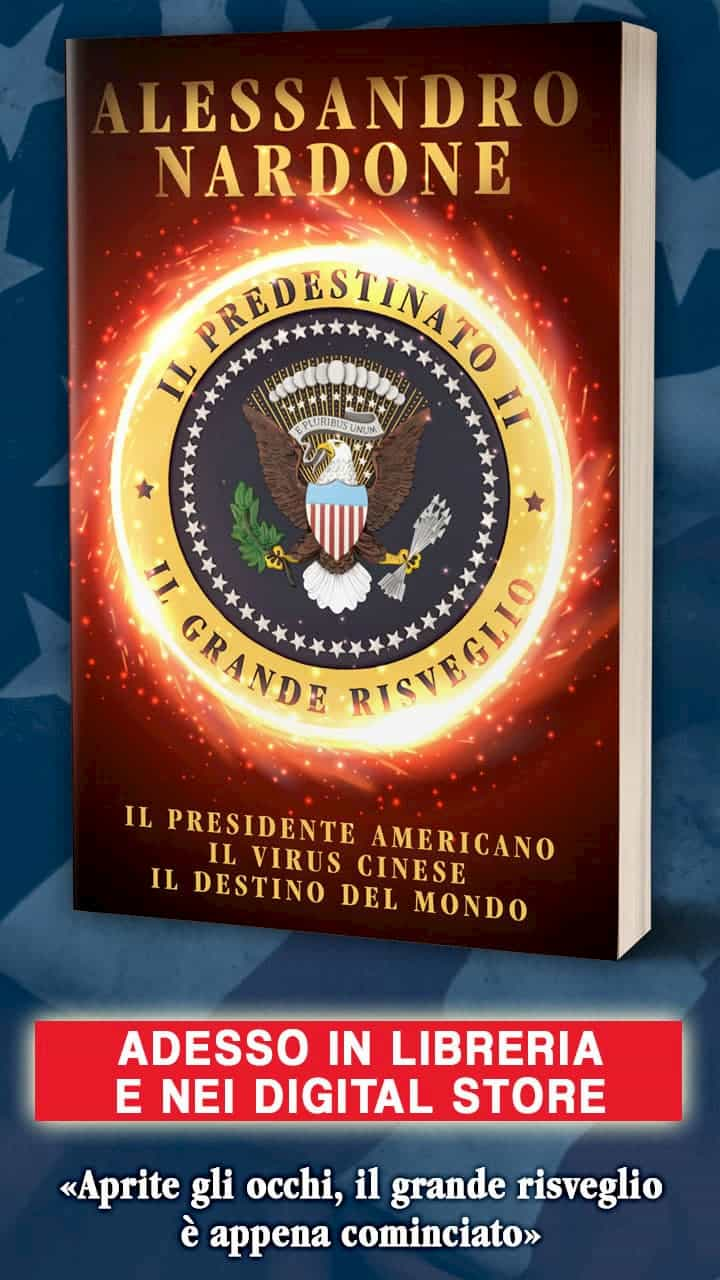Nato a Palermo e laureato a Torino, Dario Campione è tra le persone che – dal 1997 – hanno letteralmente costruito il Corriere di Como: altri tempi, altri numeri e, soprattutto, altri canali di comunicazione; il Web si era poco più che affacciato alle nostre vite ma quella, grazie alla partnership con EspansioneTv, fu una delle poche esperienze editoriali a nascere sotto la stella della crossmedialità. Tant’è che Dario, oltre a essere un autorevolissimo columnist del Corriere, è autore e conduttore di un programma televisivo di approfondimento, il Dariosauro, che si è cucito addosso puntando sulle qualità che da sempre lo hanno contraddistinto, che consistono nel coniugare una spiccata capacità di analisi a un indubbio talento nel guardare oltre la notizia e i suoi protagonisti, traendone sempre spunti di riflessione costruttivi e interessanti. In virtù del suo percorso, Dario Campione è anche docente allo IED di Como, dove insegna “Teoria e tecnica delle scritture digitali”, corso da cui è poi nata un’omonima pubblicazione di 270 pagine.
Ormai, scrivere un articolo giornalistico significa, spesso, dover trovare qualcosa che non solo possa essere interessante per il lettore, ma che abbia anche gli elementi giusti a livello di immagine (foto, video e audio) per poter diventare virale sui social: questo, a suo avviso, limita o esalta la capacità di scelta del giornalista?
Entrambe le cose. La limita perché impedisce al giornalista di concentrarsi sulla scrittura, convicendolo nel contempo che una buona immagine possa essere migliore di cento parole (cosa possibile, ma non sempre vera); la esalta perché scrivere “a corredo” di immagini talvolta evita di perdersi in inutili dettagli
Spesso si sente dire che Internet è il posto delle “fast-food news”, perché ormai gli utenti hanno poco tempo e leggono solo notizie brevi. Tuttavia, di recente, c’è chi si è inventato le “slow news” come alternativa a questo approccio. Lei da che parte sta?
Dalla parte delle slow news che però non possono esistere sul Web. La lettura digitale è per sua natura veloce. È inutile pubblicare un “romanzo” online, non lo leggerà mai nessuno.
Come scriveva Walter Lippmann, le notizie formano una sorta di pseudo-ambiente, ma le nostre reazioni a tale ambiente non sono affatto pseudo-azioni, bensì azioni reali. È evidente che il fenomeno fake news vada ben oltre le classiche “bufale” e che prolifichi a seguito della ricerca spasmodica di “like” e di visualizzazioni. Secondo lei cosa manca ai media, e ai giornalisti più in generale, per riconquistare la credibilità perduta?
Il tempo. Manca il tempo dei lettori, i quali pensano di poter conoscere il mondo facendo scivolare il pollice sullo schermo del telefonino. In generale, i media più importanti mantengono la loro credibilità, fondata sul lavoro e sull’etica dei giornalisti. Il problema è che nella società del “tutto gratis” pochissimi sono disposti a comprare le notizie. Si dà valore soltanto alle cose preziose, il cicaleccio digitale, anche inconsciamente, non può essere apprezzato.
Come detto, in Italia così come altrove, la popolarità professionale dei giornalisti (e della professione giornalistica) è ai minimi storici. Qual è, secondo lei, l’errore più grave che commettono gli operatori del settore?
Piangersi addosso.
Al di là di quello che ritiene qualche politico ci pare evidente ormai, a livello globale, che il bipolarismo non sia più tra destra e sinistra, bensì tra élite di garantiti e popolo dei non rappresentati. A questo si aggiunge il paradosso tutto italiano di una democrazia orfana degli spazi in cui una classe dirigente possa nascere e crescere per formazione e non per cooptazione. Su quali basi e con quali strumenti (anche informativi) sarà possibile – secondo lei – costruire una nuova e autentica connessione tra popolo e classi dirigenti?
Personalmente non condivido questa analisi. La “divisione” tra élite e popolo è sempre esistita, ed è stata in passato molto più profonda di quanto non sia oggi. Basta rileggere i “Quaderni” di Gramsci nella parte relativa al rapporto tra governanti e governati. Le culture politiche sussistono e, anzi, si fanno sempre più radicali. Destra e sinistra sono categorie attualissime. La classe dirigente “spontanea”, quella cioè cresciuta all’ombra di una società civile in rivolta, sta dando misera prova di sé, al punto da far rimpiangere il passato. Il tema si presenta in forme nuove a causa del cambiamento di sistema. La disputa fondamentale è oggi tra la “società aperta” e la “società chiusa”. Bisogna rileggere Popper e anche Agnes Heller per capire che il vero pericolo è costituito da chi, con il pretesto di richiamarsi al popolo, uccide la partecipazione e svuota la democrazia in nome dell’ordine, della sicurezza, della legalità. Cose già viste (purtroppo). L’informazione deve continuare a svolgere la sua funzione di sempre: raccontare i fatti e permettere ai cittadini di creare relazioni di significato. Oltre a mettere in evidenza le contraddizioni del potere.
Come accadde in passato con la televisione, oggi sono le esigenze del Web a controllare la nostra cultura e, in Internet, si vive o si muore di click, perché garantiscono potere e profitti della pubblicità. Esiste, secondo lei, un modo per superare il dualismo Google-Facebook?
Non lo so. Sicuramente occorre insistere sul tema della tassazione dei profitti delle grandi imprese digitali che utilizzano i contenuti creati da altri per ingigantire il loro “potere”.
Grazie a Snowden sappiamo che Orwell aveva ragione e che ogni singola azione che compiamo online viene intercettata, monitorata e catalogata. Questo significa controllo, che a sua volta è un sensazionale strumento di potere aumentato dalle “censure” imposte grazie ai luoghi comuni politicamente corretti. Quanto di questo “totalitarismo tecnologico”, ritiene che sia oggettivamente colpa di chi dovrebbe informare correttamente, ovvero dei giornalisti?
Alcune forme di autocensura sono sempre esistite, perché non tutti i giornalisti sono eroi e non tutti gli editori concedono libertà assoluta. Tuttavia, non è il politicamente corretto ad aver ucciso la curiosità o la voglia di fare informazione. È invece la crisi del modello di business legato alla vendita delle notizie che ha creato un baratro profondo tra giornalisti e pubblico.
Una delle suggestioni più frequenti tra gli addetti alla informazione è quella “robot journalism”, una definizione che viene associata all’uso di software in grado di realizzare testi di senso compiuto senza l’intervento dell’uomo. In prospettiva, lo vede più come un’opportunità o una minaccia?
Un’assoluta minaccia. Proprio perché, come dicevo prima, conoscere significa mettere in relazione. Un robot non potrebbe mai farlo.
Secondo lei esiste una anche remota possibilità che il giornalismo – inteso come istituzione – possa scomparire per essere sostituito da un nuovo modo di trasmettere la conoscenza alle persone magari in maniera “meccanica”, o comunque con la definitiva affermazione del principio di induzione che attualmente gli algoritmi utilizzano per “selezionare” le notizie al posto nostro?
Non credo. L’uomo ha sempre raccontato sé stesso e la sua storia. Continuerà a farlo. Il giornalismo (che non è un’istituzione ma un mestiere) è nato con gli “Avvisatori marittimi” che segnalavano o annunciavano l’arrivo in porto delle merci. È cambiato con l’avvento dell’opinione pubblica (lo ha spiegato magnificamente Habermas) e si è ingigantito grazie alle innovazioni tecnologiche. La selezione delle notizie è sempre stata necessaria perché gli spazi giornalistici (colonne sui giornali, minuti alla radio o in Tv) sono sempre stati limitati. Oggi sul Web, è un paradosso, si potrebbero scrivere in teoria tutte le informazioni possibili. Un po’ come la Biblioteca di Babele di Borges. Miliardi di libri che però nessuno leggerà mai. Perché nell’oceano delle troppe notizie si annega. Selezionare è necessario, difficile che possa farlo una macchina.
Come leggeremo le notizie tra 5 anni?
Se fossi un indovino lascerei il giornalismo per giocare al Superenalotto e poi partire per una vacanza senza fine. Forse tra 5 anni non sarà cambiato molto, tra 20 sicuramente tante cose saranno diverse.