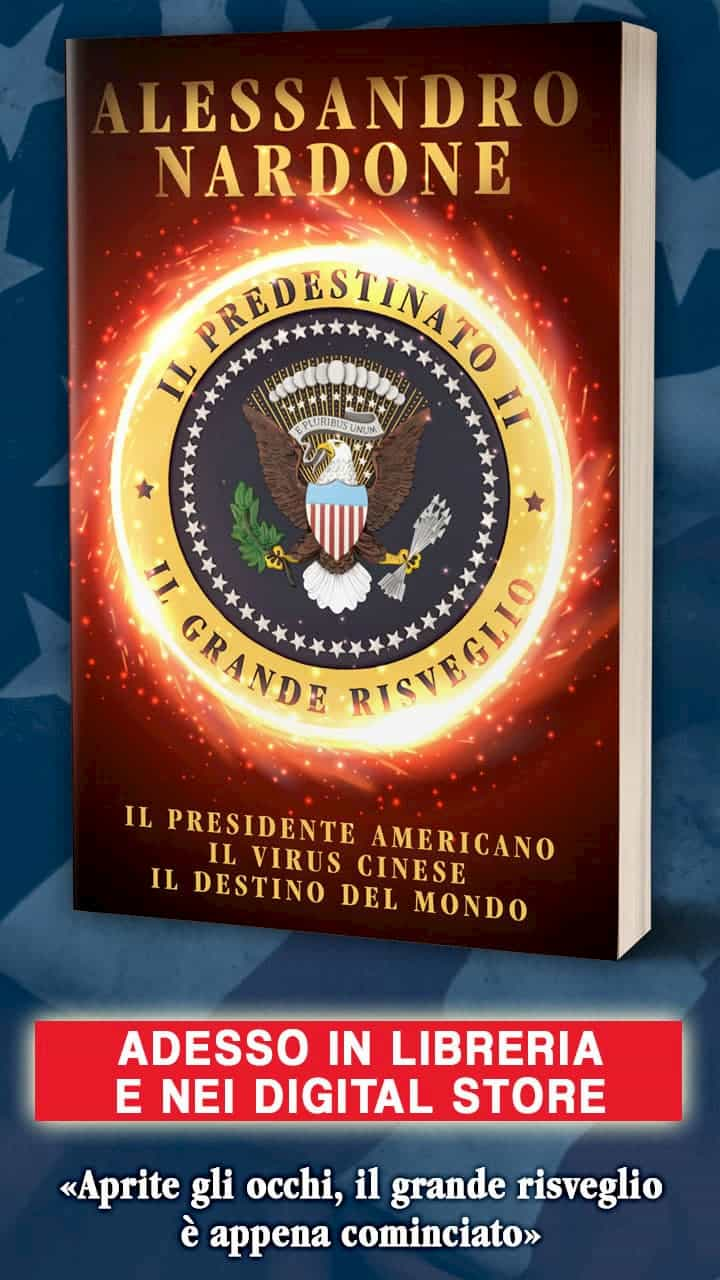Tra giornali, radio e tv, il curriculum di Francesco Specchia è certamente di quelli importanti. Tanta roba, direbbe qualcuno. Diciamo che la sua ultima creatura, PopEconomy, «piattaforma multimediale, ottimizzata per il mobile, che racconta il mondo dei numeri, dell’economia, del lavoro e del futuro come fosse un luna park», pare essere concepita come la summa del suo percorso professionale, non soltanto per i canali che utilizza (Web e tv, sul canale 224 del digitale terrestre, ndr), ma anche per un imprinting stilitico che riesce a coniugare la qualità con originalità e sintesi.
Ormai, scrivere un articolo giornalistico significa, spesso, dover trovare qualcosa che non solo possa essere interessante per il lettore, ma che abbia anche gli elementi giusti a livello di immagine (foto, video e audio) per poter diventare virale sui social: questo, a suo avviso, limita o esalta la capacità di scelta del giornalista?
Semmai la rende più creativa. Ma non è una novità: nell’800 il cronista Mark Twain per rendere più appetibili le sue notizie s’inventava le hoax (fake news più nobili e letterarie) accompagnandole spesso con dei disegni; e lo stesso accadeva con le nostre Domenica del Corriere o Cronaca Vera. L’importante è la correttezza dell’informazione e della fonte. Non importa se diventa virale un falso (per esempio l’incendio in diretta annunciato da Mentana a La7), ma importa che il lettore abbia contezza che quello è un falso…
Spesso si sente dire che Internet è il posto delle “fast-food news”, perché ormai gli utenti hanno poco tempo e leggono solo notizie brevi. Tuttavia, di recente, c’è chi si è inventato le “slow news” come alternativa a questo approccio. Lei da che parte sta?
Da quella del buon senso. Penso tutto il bene possibile delle slow news, a patto che si parli di giornalismo – o comunque narrazione – di qualità. L’esempio più recente è quello di Michele Monina, grande critico musicale, collaboratore tra l’altro di Pop Economy, che viene sempre più chiamato da siti fast-food news in cui dominano i pezzi brevissimi e gli algoritmi. Monina non scrive mai articoli pezzi al di sotto le 8000 battute; ma, essendo ben scritti, fanno sì che si riduca il tempo di rimbalzo del sito e che la gente si sosti sui portali “di transito” a 30/40 secondi a visita; ogni suo pezzo ha un tempo minimo di lettura di 3-4 minuti.
Come scriveva Walter Lippmann, le notizie formano una sorta di pseudo-ambiente, ma le nostre reazioni a tale ambiente non sono affatto pseudo-azioni, bensì azioni reali. È evidente che il fenomeno fake news vada ben oltre le classiche “bufale” e che prolifichi a seguito della ricerca spasmodica di “like” e di visualizzazioni. Secondo lei cosa manca ai media, e ai giornalisti più in generale, per riconquistare la credibilità perduta?
Il controllo delle fonti è sempre più arduo, diciamoci la verità. Noi tutti cronisti di mezz’ età, l’ultima generazione cresciuta sul sudore da suole di scarpe e sul riscontro quasi ossessivo delle fonti, potremmo chiudere il discorso imputando l’omesso controllo ai colleghi più giovani inchiodati al desk e alle fatiche del copia e incolla. Ma sarebbe una soluzione semplicistica al problema. Oggi vige il “giornalismo a rete” (definizione di Charlie Beckett): chiunque può accedere a molte fonti di informazione e allo stesso tempo «creare un contenuto informativo con bassi costi e alte potenzialità di distribuzione»: il Washington Post, a volte, vale come il blog dell’ultimo pirla. E molti di noi si rendono complici involontari di misinformazione, cioè di condivisione di informazioni false. Come se ne esce? Ti direi ricorrendo agli eterni principi del controllo delle fonti, appunto. Ma se siamo schiavi del linguaggio SEO e dei like noi stessi “vecchi”…
Come detto, in Italia così come altrove, la popolarità professionale dei giornalisti (e della professione giornalistica) è ai minimi storici. Qual è, secondo lei, l’errore più grave che commettono gli operatori del settore?
L’eccesso di infotainment, perché l’entertainment supera sempre più l’information. Altro errore sono i giornalisti che si fanno l’agente, alla stregua di divi del cinema.
Al di là di quello che ritiene qualche politico ci pare evidente ormai, a livello globale, che il bipolarismo non sia più tra destra e sinistra, bensì tra élite di garantiti e popolo dei non rappresentati. A questo si aggiunge il paradosso tutto italiano di una democrazia orfana degli spazi in cui una classe dirigente possa nascere e crescere per formazione e non per cooptazione. Su quali basi e con quali strumenti (anche informativi) sarà possibile – secondo lei – costruire una nuova e autentica connessione tra popolo e classi dirigenti?
Il bipolarismo cambia a seconda dei momenti storici: tra meridione e settentrione d’Italia (il Quotidiano del sud di Roberto Napoletano, per esempio, sta facendo una campagna assolutamente antitetica in tema di autonomie di Libero, per esempio); tra sovranisti ed europeisti; tra Lega Anseatica e Gruppo di Visegrad; tra trumpiani e putiniani. Ma in realtà è davvero il ciclo vichiano dei corsi e ricorsi. Gli ultimi che volevano costruire una sana “connessione tra popolo e classi dirigenti” erano i primi grillini, che infatti, poi, s’è visto. Non vedo all’orizzonte rivoluzioni, anche perché i paradossi tutti italiani sono legati alla memoria degl’italiani stessi che, notoriamente, è quella di un criceto.
Come accadde in passato con la televisione, oggi sono le esigenze del Web a controllare la nostra cultura e, in Internet, si vive o si muore di click, perché garantiscono potere e profitti della pubblicità. Esiste, secondo lei, un modo per superare il dualismo Google-Facebook?
Sì, quando i cinesi di Baidu decideranno di entrare anche nel nostro mercato (cosa che Jack Ma sta già pensando di fare). E allora rimpiangeremo il dualismo.
Grazie a Snowden sappiamo che Orwell aveva ragione e che ogni singola azione che compiamo online viene intercettata, monitorata e catalogata. Questo significa controllo, che a sua volta è un sensazionale strumento di potere aumentato dalle “censure” imposte grazie ai luoghi comuni politicamente corretti. Quanto di questo “totalitarismo tecnologico”, ritiene che sia oggettivamente colpa di chi dovrebbe informare correttamente, ovvero dei giornalisti?
Veramente, se è per questo, prima ancora di Orwell avevamo il Panopticom di Bentham. Eppoi tutta sfilza di prodotti dello spettacolo che vanno dal film Nemico pubblico del ’98 che m’impressionò molto, alla serie Person of Interest. Ma la colpa non soltanto quella dei soliti giornalisti. E’ di ognuno di noi che ha accettato supinamente questa innaturale invasività della tecnologia. Mi ha sconvolto, per esempio il fatto che il primo sito pornografico al mondo, Pornhub, non faccia i suoi enormi profitti non sul suo business ma sulla profilazione di ogni utente, continuativo o occasionale che lo frequenti. Se i Big Data superano il sesso, i giornalisti, stavolta, hanno colpe relative…
Una delle suggestioni più frequenti tra gli addetti alla informazione è quella “robot journalism”, una definizione che viene associata all’uso di software in grado di realizzare testi di senso compiuto senza l’intervento dell’uomo. In prospettiva, lo vede più come un’opportunità o una minaccia?
I robot serviranno per la cronaca spicciola, già funzionano su quella sportiva. Ma, anche negli approfondimenti non riusciranno mai, per quanto sofisticati, ad avere quel guizzo letterario che rende un pezzo un capolavoro. Per questo, io non mi stancherò mai di predicare la bella scrittura applicata nel giornalismo. La creatività è l’unica soluzione contro la robotizzazione del mestiere. Il giorno in cui troverò un software che scrive come Truman Capote, mollerò tutto…
Secondo lei esiste una anche remota possibilità che il giornalismo – inteso come istituzione – possa scomparire per essere sostituito da un nuovo modo di trasmettere la conoscenza alle persone magari in maniera “meccanica”, o comunque con la definitiva affermazione del principio di induzione che attualmente gli algoritmi utilizzano per “selezionare” le notizie al posto nostro?
Rimando alla risposta precedente. Non c’è solo il “dare la notizia” ma il “come darla”. Certo, considerando il grado di scrittura nel giornalismo attuale, potrebbero tranquillamente vincere gli algoritmi.
Come leggeremo le notizie tra 5 anni?
On line e via podcast. Con l’esperienza di Pop Economy sto notando anche l’importanza della divulgazione divertita in televisione e video brevi. Ma, nonostante tutto, rimarrà una nicchia di lettori cartacei che porterà, come i “libri viventi” di Fahreneit 451, la fiammella della speranza…