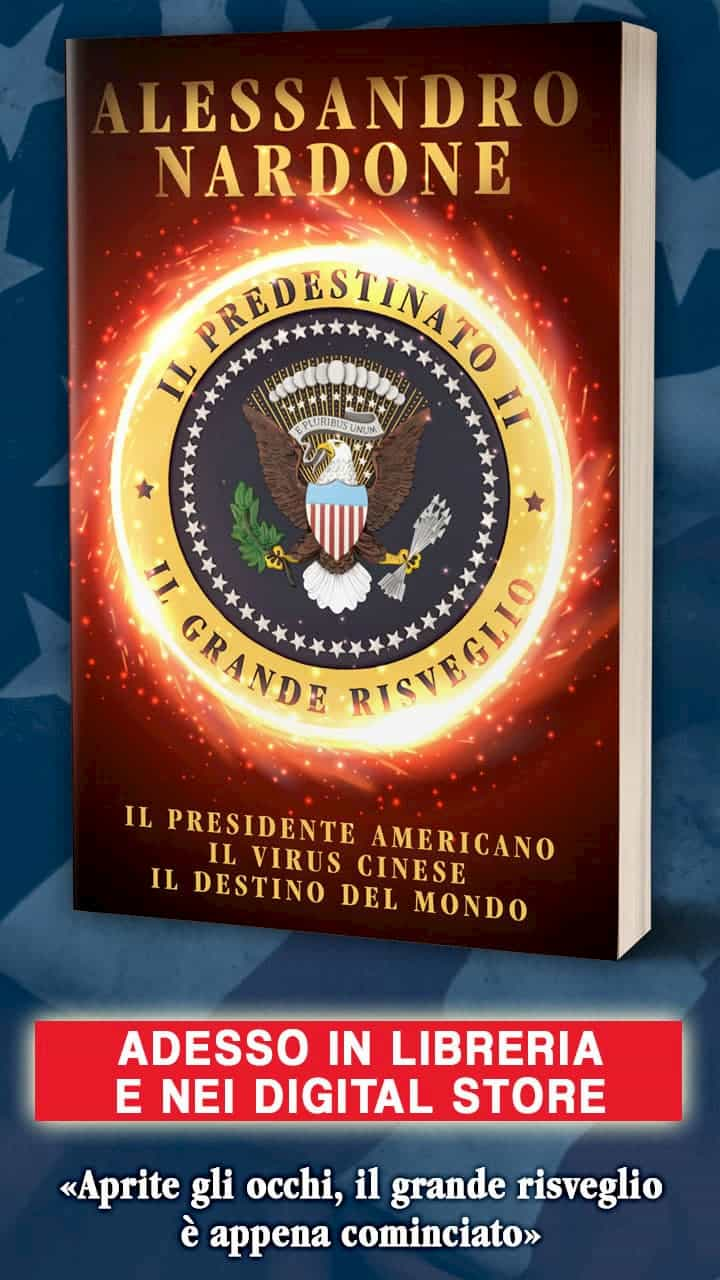Era una mattina d’estate eccezionalmente chiara. I contorni dei grattacieli apparivano di una bellezza surreale sullo sfondo dell’azzurro purissimo del cielo. New York è una città unica in qualsiasi giorno dell’anno, ma nelle mattine come quella dell’11 settembre è veramente speciale.
Mi trovavo all’Hotel Peninsula, sulla 55a strada, insieme con il mio legale oltre che vecchio amico Danny Young. Facevamo colazione con Bill Simon, che era stato mio assistente all’ufficio di U.S. Attorney, parlando dell’imminente selezione per le primarie delle elezioni a governatore della California, alle quali Bill si era candidato.
Ci stavamo salutando nella hall quando, circa un quarto d’ora prima delle nove, la detective Patti Varrone che faceva parte della scorta assegnatami dal dipartimento di Polizia ricevette una chiamata da Joe Lhota, vicesindaco con delega alle Operazioni.
Quanto è lontana dal sindaco? le chiese Joe. Un metro e mezzo, rispose lei, e Joe le disse allora che un aereo si era schiantato contro il World Trade Center. Potrebbe trattarsi di un Cessna, aggiunge ma non era ancora chiaro se si trattava di un incidente o di un attentato. Stavo ancora chiacchierando con Bill ma con la coda dell’occhio avevo notato Denny che parlava con Patti. Denny poi mi si avvicinò, e parlando a bassa voce come il suo solito, mi informò: «E’scoppiato un incendio al World Trade Center, sembra che un bimotore sia andato a sbattere contro l’edificio». Pur non avendo idea dell’enormità di quanto accaduto, Bill mi disse: «Dio ti benedica». Fu quella la prima di molte preghiere, quel giorno e nei giorni a venire.
Usciti sulla 5a strada sollevai lo sguardo sul cielo azzurrissimo e pensai: «E’ una giornata così bella, un aereo non va a colpire il World Trade Center per cause accidentali».
Poi ci fu lo schianto del secondo aereo. Ciò che vidi fu soltanto un enorme lampo di fuoco. In quel momento ci trovavamo a Canal Street, da dove ha inizio la punta meridionale di Manhattan. Sulle prime pensai si trattasse di una seconda esplosione nella stessa torre ma Patti fu informata da una telefonata della Centrale di polizia che si era trattato invece dell’altra torre: colpita, risultava, dal volo 75 della United Airlines, un 767 partito da Boston con destinazione Los Angeles. Questo ci convinse che avevamo a che fare con attentati terroristici.
Tempestammo di telefonate al centralino della Casa Bianca, ma le linee dei cellulari stavano già cominciando a intasarsi. Continuammo a correre verso il teatro della catastrofe e dal finestrino notai l’espressione sbalordita sul volto dei passanti che assistevano a quella specie di incubo in diretta.
Divisi la mia missione in tre parti.
Come prima cosa avrei dovuto comunicare con la cittadinanza, fare il possibile per calmarla e dare il mio contributo a un’evacuazione sicura e ordinata. In secondo luogo, volevo dare la massima assistenza ai feriti. A quel punto avevo capito che avremmo continuato per un paio di giorni a estrarre sopravvissuti dalle macerie e il numero dei feriti avrebbe messo in crisi i quattro ospedali della zona, cioè il St Vincent, Bellevue/NYU, NYU Downtown e Beth Israel. Intendevo quindi coordinare in un unico sistema tutti i centri medici della città, pubblici come privati. La terza parte della mia missione poteva sintetizzarsi come segue: «Che altro succederà?»
Nella montagna di servizi giornalistici dedicati alla tragedia del World Trade Center poco spazio è stato riservato a un particolare: il giorno seguente all’attacco, cioè, era prevista alla Corte federale, distante pochi isolati dalle torri, la sentenza a carico di Mohamed Rashed Daoud al-‘Owhali, un fedelissimo di Osama bin Laden. Era accusato di avere provocato la morte di 213 persone nell’attentato all’ambasciata degli Stati Uniti in Kenya.
Mi venne da piangere, ma non potevo certo farlo davanti ai giornalisti e a tutti gli altri. Me ne andai in fretta nel rudimentale ufficio che mi ero ricavato all’interno dell’accademia di Polizia, un ufficio tutt’altro che privato. Telefonai a Ted e fu quella l’unica circostanza in cui mi permisi di piangere. Per il resto della giornata non ne ebbi il tempo.
Ma anche quei tre momenti non durano più di un minuto. Dovevo concentrarmi, guardarmi attorno, affrontare mille decisioni.
Era difesa la Grand Central Station? C’erano notizie di nuovi attacchi? Come sarebbero entrati in città i macchinari edili? E da dove sarebbero venuti?
Presi, per esempio, immediatamente la decisione di lavorare sul posto giorno e notte, ventiquattr’ore su ventiquattro. Sapevo bene che le probabilità di sopravvivenza di quelli sotto le macerie sarebbero diminuite quanto più avessimo atteso e di conseguenza volevo illuminare l’intera area in modo che il lavoro non s’interrompesse, invece di fermarci alle otto di sera per riprendere l’indomani mattina alle otto. Quelle dodici ore di attività si sarebbero potute rivelare critiche, ma l’area interessata era enorme. Come avremmo fatto a illuminarla completamente? Per non parlare della difficoltà di trovare, in quelle condizioni, persone in grado di sistemare i riflettori e di portarli sul posto insieme alle altre attrezzature, con le strade intasate dalle auto abbandonate e dalle macerie.
Incaricai il vicesindaco Rudy Washington di reperire queste attrezzature e portarle sul posto, e assegnai a Richie Scheirer il compito di trovare i riflettori. Ma mi preoccupava il pensiero di nuovi attacchi: se quello alle torri faceva parte di uno sforzo coordinato per distruggere la città, i terroristi potevano essere in attesa del buio per far saltare altri edifici. Quindi aumentai il numero degli agenti in servizio notturno.
Quella sera tornai a Ground Zero e, mentre mi aggiravo tra le macerie, continuavo a fare la stessa considerazione di quelli che avevano assistito alla tragedia e alle sue conseguenze: era una specie di film, non poteva essere successo davvero.
A quel punto avevamo i riflettori in funzione e i soccorritori scavavano tra le montagne di macerie. Dalle cupe nuvole di polvere spuntava ogni tanto qualcuno di questi soccorritori, fumo e fiamme costellavano la scena e blocchi di cemento o mobili da ufficio continuavano ogni tanto a cadere dalle carcasse dei due edifici. Incontrai Bernie e continuammo a camminare in silenzio. Più di una volta chiusi gli occhi, sperando di riaprirli e ritrovare in piedi le torri. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma poi mi riscuotevo. È vero, maledizione e devo decidere che cosa fare.
In meno di due ore New York aveva perduto migliaia di vite, tra le quali quelle di centinaia di poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori, oltre al profilo cittadino più famoso al mondo. Gli abitanti avevano perso la sicurezza di vivere in una città dove le persone per bene potevano avventurarsi in strada, con la ragionevole aspettativa di tornare a casa tutte intere. Con la differenza che in questo caso la minaccia non era quella di uno scippatore o di un rapinatore o di un drogato armato di coltello.
Questo era stato il lavoro di infami terroristi, di folli convinti che uomini, donne e bambini da loro uccisi avessero qualcosa a che vedere con qualsiasi «causa» i terroristi rappresentavano.
Erano circa le 2,30 di notte quando tornai a casa del mio caro amico Howard Koeppel, dove abitavo da qualche mese. Howard aveva tenuto il televisore acceso e per la prima volta vidi come erano crollate le torri e capii quanto pericolosa e caotica fosse stata e fosse ancora la situazione.
Judith mi aveva raccomandato di fare una doccia appena tornato a casa, per lavare via la polvere, ma ero troppo stanco. Continuai a tenere acceso il televisore, con il volume al minimo, nel caso fosse successo qualcos’altro e la stampa lo fosse venuto sapere prima della polizia. Poi mi spogliai, preparando abiti e biancheria puliti da indossare in fretta se fossi dovuto uscire nuovamente durante la notte. Avevo letto da qualche questa era diventata un’abitudine per il sindaco La Guardia, e nelle due settimane successive continuai ogni sera a prepararmi.
Era una strana sensazione quella di trovarsi al 32° piano. Tenevo sul comodino la biografia di Winston Churchill scritta da Roy Jenkins, la stavo leggendo da circa una settimana. Quella notte mi riflessi i capitoli in cui lo statista descriveva la sua nomina a Primo ministro nel 1940. Pensai ai londinesi che, nonostante i continui bombardamenti, avevano tirato avanti. Pensai che era esattamente ciò che succedeva oggi in Israele. E queste considerazioni mi dettero la certezza che gli americani sarebbero riusciti a superare anche questa prova.
Mi addormentai attorno alle 4,30, per svegliarmi meno di un’ora dopo in attesa che puntasse il sole: non ero sicuro che sarebbe spuntato. E sentii un enorme sollievo quando lo vidi sorgere lentamente. Era venuta l’ora di rispondere all’attacco.
Brano tratto dal libro Leadership di Rudy Giuliani