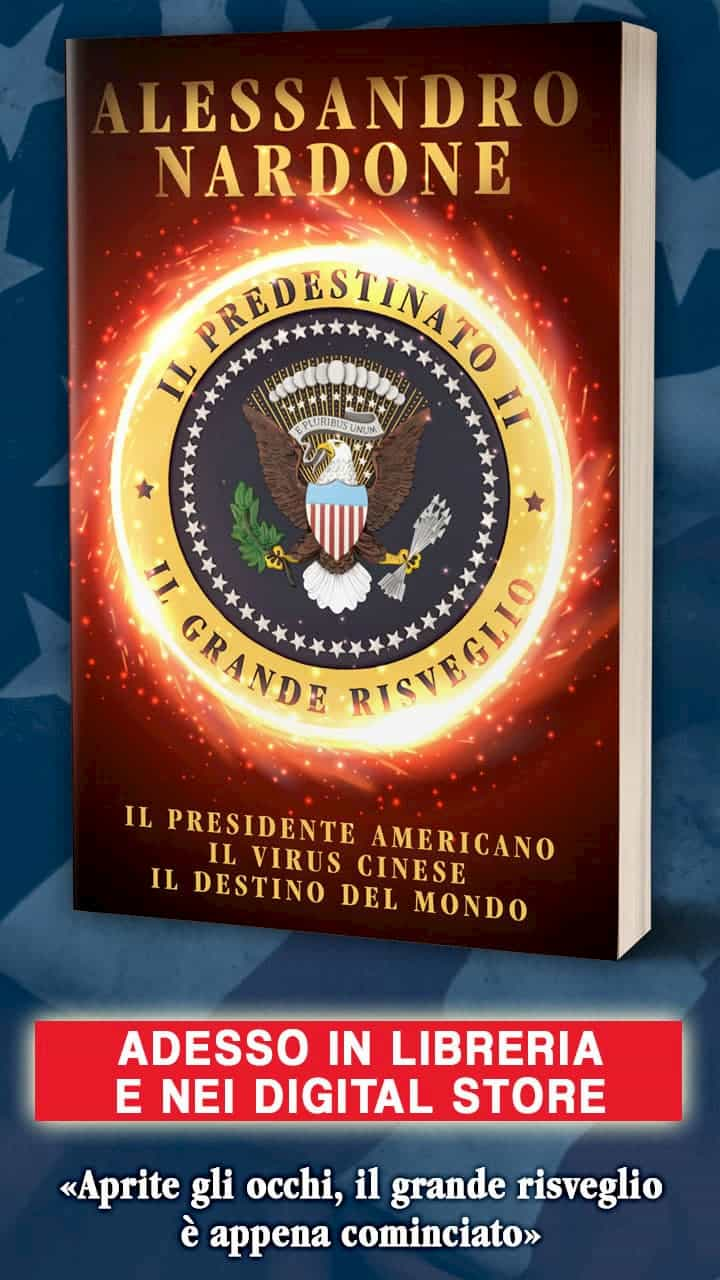Mi chiamo Edward Joseph Snowden. Un tempo lavoravo per il governo, ora lavoro per le persone. Mi ci sono voluti quasi trent’anni per capire che c’era una differenza tra le due cose e, quando è successo, ho iniziato ad avere qualche problema sul lavoro. E così adesso passo il tempo cercando di proteggere la gente dalla persona che ero una volta: una spia della Central Intelligence Agency (CIA) e della National Security Agency (NSA), un giovane tecnologo intenzionato a costruire quello che pensavo fosse un mondo migliore.
La mia carriera nell’Intelligence Community (IC) degli Stati Uniti è durata appena sette anni, solo un anno in più del tempo che finora ho trascorso in esilio in un paese che non ho scelto. Eppure, in quei sette anni ho preso parte a uno dei cambiamenti più significativi nella storia dello spionaggio americano: il passaggio dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla sorveglianza di massa di intere popolazioni.
Ho contribuito a che fosse tecnologicamente possibile, per un singolo governo, raccogliere le comunicazioni digitali di tutto il mondo, conservarle per anni e utilizzarle a suo piacimento.
Dopo l’11 settembre, l’IC era tormentata dal senso di colpa per non essere riuscita a proteggere gli Stati Uniti e a impedire uno degli attacchi più devastanti subiti dal paese dopo Pearl Harbor. Fu allora che i capi dell’agenzia decisero di ideare un sistema per evitare di essere di nuovo colti di sorpresa. La base di questo sistema sarebbe stata la tecnologia, una disciplina del tutto sconosciuta agli esperti di scienze politiche e di gestione aziendale che riempivano le file dell’organizzazione. E così, una delle agenzie di intelligence più segrete in assoluto spalancò le porte a giovani tecnici informatici come me. E i nerd presero le redini del mondo.
Se c’era una cosa che conoscevo bene a quel tempo erano i computer, perciò feci strada molto velocemente. A ventidue anni ottenni il mio primo nullaosta di livello top secret all’NSA, anche se ero in una posizione molto bassa nell’organigramma dell’agenzia. Meno di un anno dopo ero alla CIA in qualità di ingegnere informatico, e avevo libero accesso ad alcuni dei sistemi informatici più segreti al mondo. Il mio unico supervisore era un tipo che passava il tempo a leggere i libri di Robert Ludlum e Tom Clancy.
Nel reclutare giovani talenti informatici, le agenzie avevano derogato alle loro regole interne. Di solito non assumevano chi non possedeva una laurea o perlomeno un associate degree, e io non avevo né l’una né l’altro; teoricamente non avrei potuto nemmeno mettere piede in un loro edificio. Dal 2007 al 2009 svolsi un incarico all’ambasciata statunitense di Ginevra.
Ero uno dei pochissimi tecnici sotto copertura diplomatica e il mio compito era quello di condurre la CIA nel futuro, portando online le sue basi operative europee, e digitalizzando e automatizzando la rete attraverso la quale il governo statunitense conduceva l’attività di spionaggio. La mia generazione, insomma, non ha soltanto riprogettato il lavoro di intelligence, ma ne ha ridefinito il concetto stesso. Il nostro lavoro non riguardava incontri clandestini o punti di scambio segreti; riguardava unicamente i dati.
A ventisei anni ero ufficialmente un impiegato della multinazionale Dell, ma in realtà continuavo a lavorare per l’NSA tramite contratti d’appalto, così come quasi tutti i tecnici-spia della mia cerchia. Mi inviarono in Giappone, dove contribuii a progettare l’intero sistema di backup dell’agenzia, un immenso impianto informatico che consentiva di non perdere nessun dato, nemmeno se la sede dell’NSA fosse stata ridotta in cenere da un attacco nucleare.
Allora, però, non mi rendevo conto di quale tragico errore fosse ideare un sistema che permetteva di conservare una traccia permanente della vita di ognuno di noi.
A ventott’anni tornai negli Stati Uniti e ricevetti una promozione stratosferica, entrando a far parte della squadra tecnica di Dell che gestiva i rapporti con la CIA. Il mio lavoro consisteva nel collaborare con i capi dei reparti tecnici dell’agenzia al fine di progettare e offrire soluzioni a qualsiasi tipo di problema mi ponessero davanti. Il mio team aiutò la CIA a realizzare un nuovo tipo di architettura informatica: il cloud, la prima tecnologia che permetteva a ogni agente, ovunque si trovasse fisicamente e qualunque fosse la distanza, di accedere a tutti i dati di cui aveva bisogno.
In poche parole, all’inizio il mio compito era stato quello di gestire e connettere il flusso di informazioni, poi di conservarle per sempre e infine di renderle universalmente accessibili. Mi resi davvero conto dei progetti a cui avevo lavorato soltanto quando mi trovavo alle Hawaii, dove mi ero trasferito a ventinove anni in seguito a un nuovo contratto stipulato con l’NSA. Fino a quel momento avevo operato secondo il principio del need-to-know, e non ero quindi nella posizione di comprendere lo scopo più ampio di quegli incarichi così specifici e divisi in compartimenti stagni. Fu solo quando mi trovai in quel paradiso che riuscii finalmente ad avere un quadro complessivo dei miei incarichi, che erano gli ingranaggi di una macchina gigantesca e andavano a formare un vero e proprio sistema di sorveglianza di massa.
Mi trovavo in un tunnel situato sotto una piantagione di ananas (un’ex fabbrica sotterranea di aeroplani dell’epoca di Pearl Harbor), seduto di fronte a un terminale che mi dava accesso illimitato alle conversazioni di quasi ogni uomo, donna e bambino che avesse mai fatto una telefonata o toccato un computer. Tra queste persone c’erano i miei circa 320 milioni di connazionali che ogni giorno, mentre conducevano regolarmente le loro vite, venivano sorvegliati, in violazione non soltanto della Costituzione degli Stati Uniti ma dei principi fondamentali che stanno alla base di qualunque società libera.
Il motivo per cui state leggendo questo libro è perché ho fatto qualcosa di molto pericoloso, per uno nella mia posizione: ho deciso di dire la verità. Ho raccolto i documenti interni dell’IC che dimostravano le attività illegali del governo statunitense e li ho passati ai giornalisti, che li hanno esaminati e poi pubblicati, provocando uno scandalo mondiale.
In questo libro racconterò che cosa mi ha spinto a prendere una simile decisione, quali valori mi hanno guidato e in che modo questi valori si sono formati dentro di me. Quindi, di fatto, racconterò la mia vita. Di che cosa è fatta una vita? Non soltanto di quello che diciamo; né di ciò che facciamo. La nostra vita sono anche le cose che amiamo e in cui crediamo.
Per quanto mi riguarda, la cosa che amo e in cui credo di più è l’interconnessione, la connessione tra gli uomini, e le tecnologie che la rendono possibile. Queste tecnologie comprendono anche i libri, ovvio. Ma per la mia generazione, connessione significava innanzitutto Internet. So bene quale luogo tossico e insano sia diventato oggi il Web, ma dovete capire che per me, quando ci sono entrato in contatto per la prima volta, Internet era qualcosa di totalmente diverso. Era come un amico, un genitore.
Una comunità senza confini né limiti, milioni di voci che confluivano in una sola, un terreno vergine condiviso – ma non sfruttato – da varie comunità che vivevano fianco a fianco in modo amichevole, i cui membri erano liberi di scegliere il proprio nome, la propria storia e le proprie abitudini. Tutti indossavamo delle maschere, eppure questa cultura dell’«anonimato attraverso la polionimia» produceva più verità che falsità, perché aveva un carattere creativo e cooperativo, più che commerciale e competitivo. C’erano dei conflitti, ovviamente, ma a prevalere erano sempre la gentilezza e i buoni sentimenti, come il vero spirito pionieristico richiede.
Mi capirete, quindi, se dico che oggi Internet è diventata irriconoscibile. Questo cambiamento è il risultato di una scelta consapevole e di sforzi sistematici da parte di un’élite privilegiata.
La repentina evoluzione del commercio in e-commerce ha portato alla creazione di una bolla che sarebbe prontamente scoppiata con l’avvento del nuovo millennio. A quel punto le aziende capirono che le persone, quando si trovavano online, erano più interessate a condividere che a spendere, e che la connessione umana che Internet aveva reso possibile poteva essere monetizzata.
Se su Internet la gente non voleva far altro che dire ad amici, familiari e sconosciuti che cosa stesse facendo (e a sua volta sapere che cosa stessero facendo amici, familiari e sconosciuti), allora le aziende dovevano semplicemente trovare il modo di inserirsi in questi scambi sociali e trarne profitto. È così che è iniziato il capitalismo di sorveglianza, decretando la fine di Internet per come la conoscevo io.
In quel momento è stato il Web creativo a collassare, con la scomparsa di numerosi siti indipendenti, bellissimi e complessi. La gente, attirata dalla maggiore facilità d’uso, ha preferito abbandonare i propri siti personali – che richiedevano un costante lavoro di manutenzione – a favore di pagine Facebook o account Gmail, dei quali, però, erano proprietari solo nominalmente. Pochi di noi allora se ne resero conto, ma ormai non ci apparteneva più niente di quello che condividevamo. Chi era succeduto alle società che avevano fallito nell’e-commerce, perché non erano riuscite a trovare nulla che ci interessasse comprare, ora aveva un nuovo prodotto da venderci.
Quel prodotto eravamo noi stessi. I nostri interessi, le nostre attività, la nostra posizione e i nostri desideri – insomma tutto ciò che rivelavamo, in modo più o meno consapevole – venivano sorvegliati e rivenduti, però in segreto, così da rimandare il più possibile l’inevitabile sensazione di essere stati violati, che per molti di noi sopraggiunge solo adesso.
Questo tipo di sorveglianza avrebbe continuato a essere incoraggiata, e persino finanziata, dai tanti governi avidi dell’enorme quantità di informazioni ricavabili. Fatta eccezione per le procedure di login e le transazioni finanziarie, nei primi anni del Duemila quasi nessun genere di comunicazione online era criptato, il che significa che in molti casi i governi non avevano bisogno di rivolgersi alle aziende per sapere cosa stessero facendo i loro clienti.
Potevano spiare il mondo senza che nessuno se ne accorgesse. Il governo americano, nel più totale disprezzo dei principi della Carta costituzionale, ha ceduto alla tentazione e, una volta assaggiato il frutto dell’albero avvelenato, è stato colto da una smania irrefrenabile. Ha assunto in segreto il controllo della sorveglianza di massa, un’autorità che, per definizione, affligge più gli innocenti che i colpevoli.
Quando mi resi pienamente conto di questo tipo di controllo e dei suoi effetti dannosi, fui perseguitato dalla consapevolezza che a nessuno di noi – ai cittadini non solo di una nazione, ma di tutto il mondo – era mai stato concesso il diritto di esprimere la propria opinione sull’argomento tramite un voto o in qualche altra maniera. Non solo questo sistema di sorveglianza su scala mondiale era stato messo in piedi senza il nostro consenso, ma ogni aspetto del suo funzionamento ci veniva deliberatamente nascosto.
Nessuno, nemmeno la maggioranza dei legislatori era a conoscenza dei continui cambiamenti di procedura e delle relative conseguenze. A chi avrei potuto rivolgermi? Con chi avrei potuto parlare? Avrei commesso un reato gravissimo se avessi svelato come stavano le cose, persino se ne avessi parlato con un avvocato, un giudice o di fronte al Congresso; bastava un semplice accenno ai fatti più generici e avrei dovuto scontare l’ergastolo in una prigione federale.
Mi sentivo perso e abbattuto, mentre cercavo di fare i conti con la mia coscienza. Amavo il mio paese e credevo nel servizio pubblico; per generazioni la mia famiglia è stata composta di uomini e donne che hanno dedicato la loro vita a servire questo paese e i suoi cittadini. Io stesso ho giurato di servire non un’agenzia e nemmeno il governo federale, ma il popolo, in sostegno e difesa della Costituzione, la cui promessa di garantire le libertà civili è stata invece violata. E io non soltanto avevo preso parte a quella violazione: ne ero il responsabile.
Tutto quel lavoro, per tutti quegli anni… Per chi stavo lavorando? Come potevano convivere l’obbligo di segretezza verso le agenzie che mi avevano assunto e il giuramento che avevo prestato verso i principi costituzionali del mio paese? A chi, o a cosa, dovevo la mia lealtà? Fino a che punto ero moralmente obbligato a infrangere la legge? Riflettendo su queste domande, ho trovato le risposte che cercavo.
Ho capito che uscendo allo scoperto e rivelando ai giornalisti gli abusi perpetrati dal mio paese, non avrei decretato la fine del governo né quella dell’IC, ma avrei invece consentito al governo e all’IC di tornare a perseguire i propri ideali. La libertà di un paese si può misurare soltanto in base al rispetto verso i diritti dei propri cittadini, e io credo che tali diritti rappresentino delle restrizioni al potere dello Stato, perché stabiliscono fin dove può spingersi un governo senza invadere quel territorio proprio dell’individuo che durante la rivoluzione americana era chiamato libertà, mentre nella rivoluzione di Internet corrisponde alla privacy.
Sono passati sei anni da quando ho deciso di uscire allo scoperto, dopo aver visto i cosiddetti paesi avanzati impegnarsi sempre di meno per tutelare la privacy dei propri cittadini, privacy che non solo io, ma anche le Nazioni Unite considerano uno dei diritti umani fondamentali.
In questi anni, con lo svilimento della democrazia in populismo autoritario, questo impegno ha continuato a diminuire; una regressione che appare evidente soprattutto nel rapporto tra i governi e la stampa. I tentativi dei funzionari eletti di delegittimare i giornalisti sono stati accompagnati e sostenuti da un duro attacco al concetto di verità.
I fatti reali vengono accostati di proposito a quelli inventati, attraverso tecnologie in grado di trasformare questo amalgama in una confusione generale senza precedenti. Conosco molto bene questo processo, perché la creazione dell’irrealtà è sempre stata una delle arti più oscure dell’Intelligence Community.
Si tratta delle stesse agenzie – e parlo solo di cose accadute mentre lavoravo per loro – che hanno manipolato le informazioni al fine di ottenere pretesti per scatenare guerre, e che tramite politiche illegali e procedure giudiziarie poco trasparenti hanno potuto compiere sequestri di persona chiamandoli «consegne straordinarie», mentre le torture erano «interrogatori avanzati» e la sorveglianza di massa una semplice «raccolta dati»; inoltre non hanno esitato a definirmi una spia al soldo dei cinesi, poi dei russi, e ancora peggio, un «millennial».
Se hanno potuto dire tutto questo, e in modo così libero, è perché mi sono rifiutato di difendermi. Dal momento in cui ho deciso di dire la verità, mi sono ripromesso di non rivelare mai alcun dettaglio della mia vita personale che potesse causare ancora più dolore alla mia famiglia e ai miei amici, già messi alla prova dalle mie scelte di principio. Il timore di accrescere la loro sofferenza mi ha inoltre instillato notevoli dubbi sull’opportunità di scrivere questo libro.
È stato più facile uscire allo scoperto mostrando le prove dei reati commessi dal governo che non decidere di raccontare la mia vita. Gli abusi e gli illeciti a cui ho assistito richiedevano un’aperta presa di posizione, ma nessuno scrive un’autobiografia perché non riesce a resistere alla voce della propria coscienza. Per questo motivo ho voluto chiedere il permesso a ogni membro della mia famiglia, amico e collega che viene nominato in queste pagine, o che potrebbe essere riconosciuto a partire da ciò che scrivo.
Dal momento che non ritengo di poter decidere della privacy di qualcun altro, allo stesso modo non ho mai pensato di dover scegliere io quali segreti del mio paese rivelare al pubblico e quali no. È per questo che ho mostrato i documenti del governo esclusivamente ai giornalisti, senza renderli noti al pubblico in via diretta. Come questi giornalisti, anch’io ritengo che un qualsiasi governo possa arrogarsi il diritto di tenere segrete alcune informazioni.
Persino le democrazie più trasparenti al mondo dovrebbero celare, per esempio, l’identità dei propri agenti sotto copertura o tacere dei movimenti delle truppe impegnate in battaglia. Ma non è questo il genere di segreto di cui si tratta in questo volume. Il mio compito, seppur non facile, è di raccontare la mia vita cercando di proteggere la privacy delle persone che amo ed evitando di svelare i segreti legittimi del governo.
È qui, tra queste due responsabilità, che mi trovo io.
brano tratto dal libro Errore di sistema, di Edward Snowden