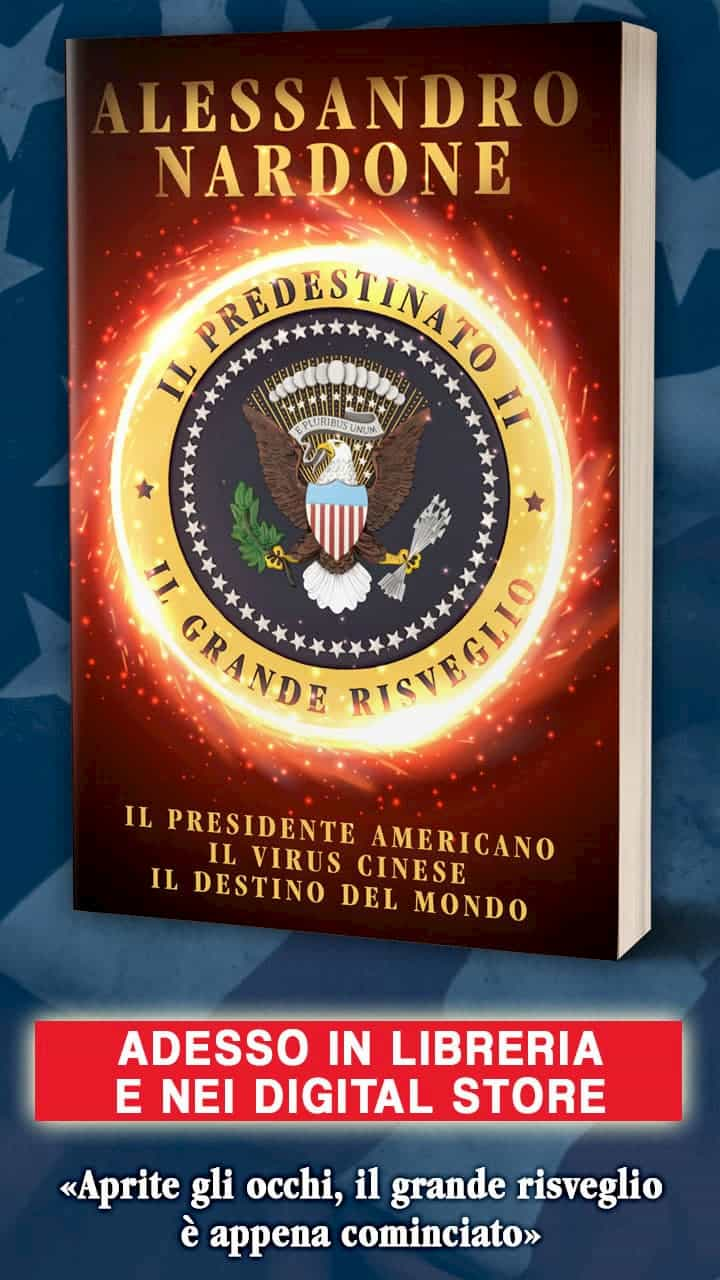Si è aperto a Londra, due giorni fa, il processo contro il fondatore di Wikileaks, Julian Assange. Si tratta del primo passo verso la richiesta d’estradizione, inoltrata dagli Usa alle autorità britanniche, nei confronti dell’editore-hacker australiano reo di aver “cospirato” (in collaborazione con Chelsea Manning) contro gli interessi nazionali statunitensi.
Un’udienza, peraltro, a cui sono seguite le proteste dell’avvocato di Assange, Edward Fitzgerald, per il trattamento crudele, inumano e degradante subito dal suo assistito nel carcere di massima sicurezza dove è rinchiuso.
«Julian Assange è stato ammanettato a più riprese e denudato due volte per essere perquisito nella giornata di ieri dallo staff della prigione di massima sicurezza britannica di Belmarsh in cui è detenuto in attesa del verdetto della giustizia del Regno sulla sua consegna agli Usa». Fitzgerald ha rincarato la dose sostenendo che «Un simile trattamento minaccia di impedire ad Assange di partecipare alle prossime udienze». Anche a fronte, è bene ricordarlo, delle precarie condizioni psicofisiche del fondatore di Wikileaks.
L’accusa rivolta a uno degli uomini più braccati e inseguiti del pianeta, è di aver divulgato in forma anonima video e documenti segreti riguardanti le operazioni militari americane in Iraq e Afghanistan, circostanza capace di svelare gli orrori più sordidi della guerra agli occhi del mondo e di rendere vulnerabili i servizi di sicurezza nazionali.
Tuttavia, il processo nei confronti di Assange assume una valenza che va al di là della controversia giudiziaria con Washington, e riguarda, tema decisamente più importante, i riflessi e le conseguenze che questa vicenda assumerà per la libertà di stampa.
Dopo la revoca dell’asilo umanitario con cui, vigliaccamente, il governo ecuadoriano ha consentito l’arresto di Assange e l’inizio di un nuovo calvario (dopo l’autoisolamento iniziato nel giugno del 2012), il mondo dell’informazione rischia di non essere più lo stesso.
Il motivo in sé è molto semplice. Dall’esito di questo processo (politico), infatti, dipenderà il rapporto (non solo riferito agli Stati Uniti) tra editori, giornalisti e le loro fonti.
E capiremo, altresì, se il mondo del giornalismo sarà ancora al riparo da sciagurate conseguenze.
Eppure, una buona fetta della stampa (soprattutto quella mainstream tanto cara alle élite), poco incline a piegare il capo davanti a un competitor con privilegi d’accesso a informazioni classificate “top secret”, ha immediatamente manifestato una certa malcelata insofferenza nei confronti del biondo australiano, sostenitore della trasparenza totale (per meglio intenderci, della pubblicazione integrale dei documenti).
Uno scontro tanto aspro quanto inutile, perché l’esperienza di Wikileaks ha dimostrato, piaccia o meno, che la professione del giornalista è cambiata.
È necessario interrogarsi, dunque, sul tipo d’informazione preferita dal lettore, unico giudice imparziale e insindacabile.
Privilegia la grancassa suonata da giornalisti abili portavoce dei potenti, oppure, quella propugnata dall’emaciato australiano tesa a svelare i crimini di guerra, le menzogne, la corruzione e lo sperpero di denaro, senza comodi appoggi o particolari salvacondotti per le proprie terga?
«Mi piace aiutare le persone vulnerabili, mi piace fare a pezzi i bastardi», dichiarò Assange al settimanale tedesco “Der Spiegel” in una delle sue frasi più celebri e riuscite.
Nascosta, all’interno di quell’affermazione tanto forte, si cela un appello accorato, una richiesta d’aiuto: la convinzione che ai malvagi debba rispondere la società civile, quella per intenderci che si oppone all’establishment, ai governi bugiardi, ai mercanti di morte.
Sostenere figure come Assange, Manning e, soprattutto, Snowden significa riportare il dominio dell’informazione sotto il controllo dei cittadini evitando subdole e odiose manipolazioni.
“I love WikiLeaks” commentò beffardo, nel 2016, il presidente Trump.
Bene, vediamo se saprà dimostrarlo.