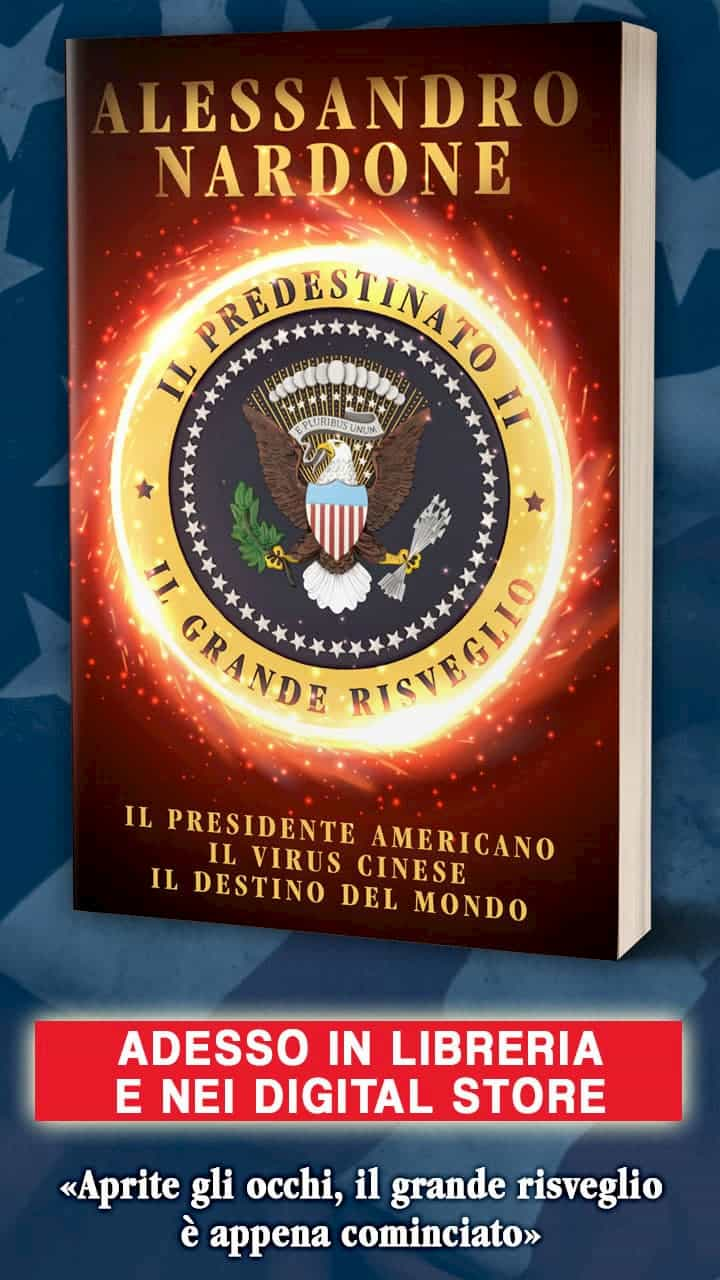All’inizio della scorsa campagna elettorale Donald Trump non piaceva nemmeno a me, tant’è che grazie alla mia esperienza nei panni del candidato Alex Anderson lui e la Clinton erano i miei bersagli preferiti. «Ogni voto a Trump è un voto a Hillary Clinton» era lo slogan contenuto in uno dei miei tweet, che il giorno successivo fu copiato pari pari da un candidato “vero”, il repubblicano Marco Rubio.
Attenzione: quella mia campagna fake non durò un giorno ma nove mesi, nel corso dei quali ebbi modo di entrare in contatto con decine di migliaia di elettori dell’area che oggi conosciamo come alt-right, ovvero la destra alternativa il cui maître à penser è quello Steve Bannon che fu capace di conferire al trumpismo la matrice identitaria che ancora non aveva.
Un vero e proprio popolo fatto di donne e uomini che con il passare delle settimane si sono stretti sempre di più attorno al loro nuovo leader anche grazie al contributo della stessa Clinton, autrice di autogol colossali come quando associò i repubblicani ai «gruppi terroristici» e apostrofò come «deplorevoli» i supporter del suo avversario, che da par loro presero quell’aggettivo dispregiativo e ne fecero un vero e proprio brand anti-establishment.
Durante quei mesi ebbi la possibilità di assistere da una posizione assolutamente privilegiata alla nascita del fenomeno politico destinato a cambiare i connotati non soltanto degli Stati Uniti, ma dell’intero pianeta.
Una delle caratteristiche che consentirono al “mio candidato” di ottenere quell’enorme successo fu la scelta di rispondere a chiunque gli scrivesse, anche per insultarlo. Si chiama comunicazione orizzontale. Risultato: ogni santa notte per nove mesi mi confrontai direttamente con centinaia di americani, dibattendo con loro dei temi più importanti della campagna elettorale.
Immigrazione, economia, Secondo Emendamento, diritto alla vita, ma anche privacy (argomento che era in cima al mio programma, dal momento che Edward Snowden era il mio candidato vice) e lotta al pensiero unico. Su molti temi andavamo d’accordo, su altri decisamente meno, ma ciò non toglie che quell’esperienza mi consentì di sintonizzarmi sulle loro frequenze comprendendo le reali ragioni che stavano alla base delle loro battaglie.
Quando, dopo essere uscito allo scoperto, venni ingaggiato da Vanity Fair per andare alla Convention Repubblicana di Cleveland, in un certo senso fu come ingoiare la pillola rossa di Matrix: dopo essere sceso dall’aereo mi trovai proiettato dalla dimensione virtuale a quella reale della campagna elettorale, avendo la possibilità di conoscere personalmente alcuni degli artefici della cavalcata trionfale di Trump, con l’enorme vantaggio che molti di loro già conoscevano me.
Questo mi consentì di essere invitato ad alcuni importanti eventi “a porte chiuse”, ovvero riservati ai delegati repubblicani, tra cui quello organizzato dall’American Conservative Union Foundation, una potente organizzazione di area repubblicana vicina alla NRA, durante il quale conobbi, tra gli altri, Mike Pence e Kellyanne Conway poi diventati, rispettivamente, vicepresidente e consigliere del presidente.
Giusto per fare un esempio, in quella circostanza compresi per la prima volta quanto la base repubblicana rivedesse in Trump la figura di Ronald Reagan.
«Su internet troverete una mia vecchia immagine, in cui probabilmente avevo l’età che oggi ha mio figlio, che mi ritrae insieme al Presidente Reagan – esordì Pence nel suo intervento – conoscevo Reagan, conosco l’uomo Trump e conosco il suo cuore. E fidatevi se vi dico che lui mi ricorda in tutto e per tutto Ronald Reagan».
Pence ha poi continuato definendo Trump «un costruttore e un combattente, un padre e un patriota. Sarà un grande presidente degli Stati Uniti d’America, perché il suo cuore batte con il cuore del popolo americano».
– Continua domani