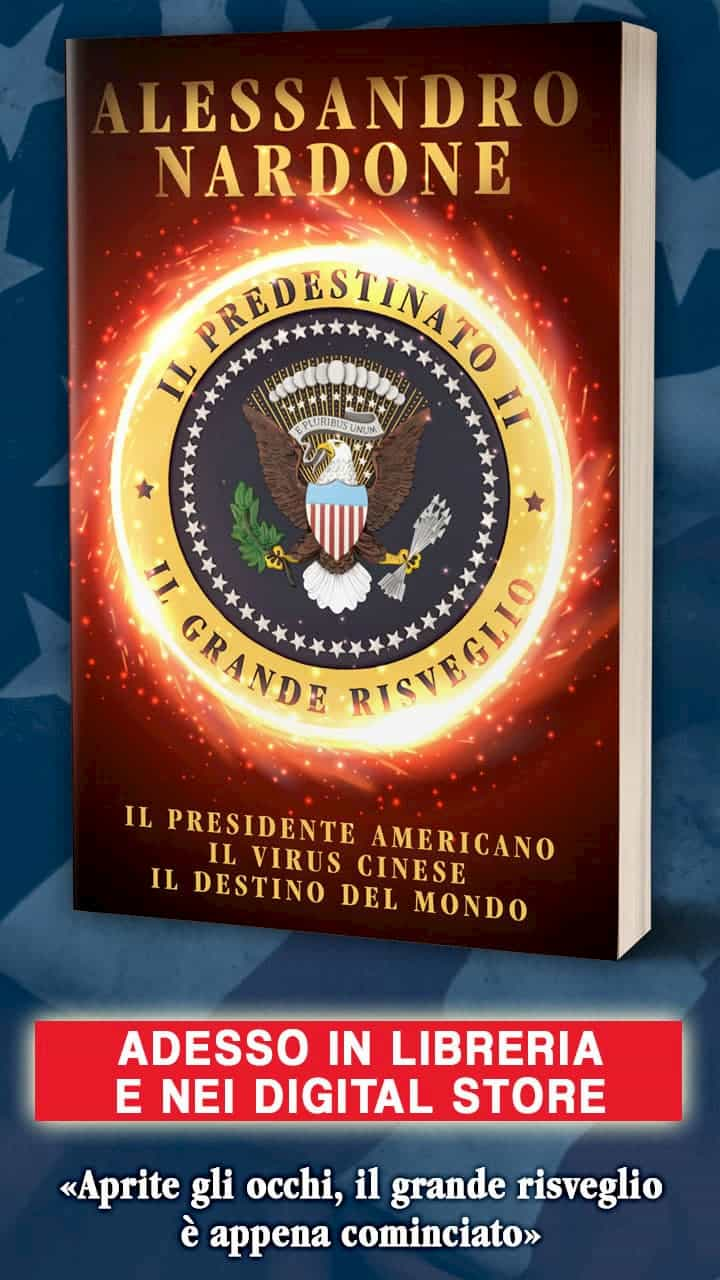Solo un pazzo guarderebbe i sondaggi di giugno e li prenderebbe come una previsione delle elezioni del 3 novembre. Eppure oltreoceano in molti credono che i sondaggi, nuovamente, possano essere la fonte della verità assoluta.
Nel 2016, fino alla chiusura delle urne, alcuni fra i più accreditati istituti davano fra il 70% e il 98% di possibilità di vittoria a Hillary Clinton. Inutile ripetere la storia che tutti quanti conoscono fin troppo bene, piaccia o meno.
Esistono alcuni sondaggi, addirittura, che vedono Joe Biden in vantaggio di 14 punti percentuali su Donald Trump. Per i poco pratici, 14 punti equivalgono a vittorie in: Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Ohio, Pennsylvania e Wisconsin. E, fin qui, tutto normale. Normale perché gli stati citati sono degli swing states che già nel 2016 sono stati vinti per pochi punti. Il problema arriva quando a Biden finiscono anche Iowa e Georgia.
Per gli amanti della matematica, il quadro sarebbe questo: 373 Biden, 165 Trump. Al Presidente resterebbe la magra consolazione di portare a casa il Texas per il rotto della cuffia: esattamente lo 0.3%, stando alle stime di FiveThirtyEight. Si desume, quindi, che da qui a novembre quello 0.3% possa diventare magari a favore di Biden. In quel caso la matematica direbbe: 411 Biden, 127 Trump. Un disastro senza precedenti.
A quel punto, più che di sconfitta, dovremmo parlare di colossale batosta.
È vero, Biden è il primo sfidante che cinque mesi prima delle elezioni ha più di 10 punti percentuali di vantaggio. Prima di lui solo tre Presidenti in carica tutti rieletti: Nixon nel 1972, Reagan nel 1984 e Clinton nel 1996. Questo, però, non dovrebbe far cullare sugli allori i democratici.
Anzitutto perché in questo stesso momento, esattamente venti anni fa, George W. Bush era dato in vantaggio di 8 punti su Al Gore e, a novembre, ha poi perso il voto popolare e vinto la Presidenza grazie ad una sentenza della Corte Suprema «applicata al singolo caso» sulle 537 schede di scarto in Florida.
Non è tutto, chiaramente.
In questo momento chiunque preferirebbe essere Joe Biden e non Trump.
Il Presidente paga una altalenante gestione della crisi pandemica e il crollo economico che ne è conseguito. E, come ogni elezione presidenziale che si rispetti, il 3 novembre sarà un referendum su Trump stesso.
Fino alle Convention, dunque, Biden può anche far finta di non essere in campagna elettorale e può continuare a condurre il suo spettacolo dal suo stanzino nella sua casa in Delaware. Ad un certo punto, però, i riflettori saranno puntati su di lui e non potrà più far finta che essi non esistano.
Va dato un merito all’ex Vicepresidente: ha capito – non sappiamo se per merito suo o per merito di chi gli sta intorno – che restare in silenzio è la migliore tattica che può utilizzare al momento. Come anticipato sopra, però, arriverà un momento – presumibilmente il primo dibattito – in cui Biden dovrà per forza stare sotto le luci che queste sfide impongono.
A quel punto dovrà obbligatoriamente dimostrare di essere capace di poter superare tutte quelle prove che gli si presenteranno davanti, prima fra tutte i dibattiti e la più che contestata – e a tratti palese – assenza di carisma.
Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno subito di tutto: pandemia – 2.584.677 casi totali e 127.995 morti[1] –, crisi economica e del lavoro – stima PIL secondo trimestre pari del -34%[2] e 19.522.000[3] milioni di persone che hanno ottenuto il sussidio di disoccupazione – e questione razziale. Alla fine ci sarà un vaccino efficace, l’economia si riprenderà e si stanno compiendo passi in avanti sulla riforma della polizia e le questioni annesse.
Resta da chiedersi se, però, tutto questo arriverà in tempo per la volata finale di Trump oppure se, come per magia, la vita restituirà a Biden qualcosa dopo avergli tolto letteralmente (quasi) tutto.
[1] Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (dato del 27/06/2020 alle 22:20)
[2] Goldman Sachs
[3] Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America