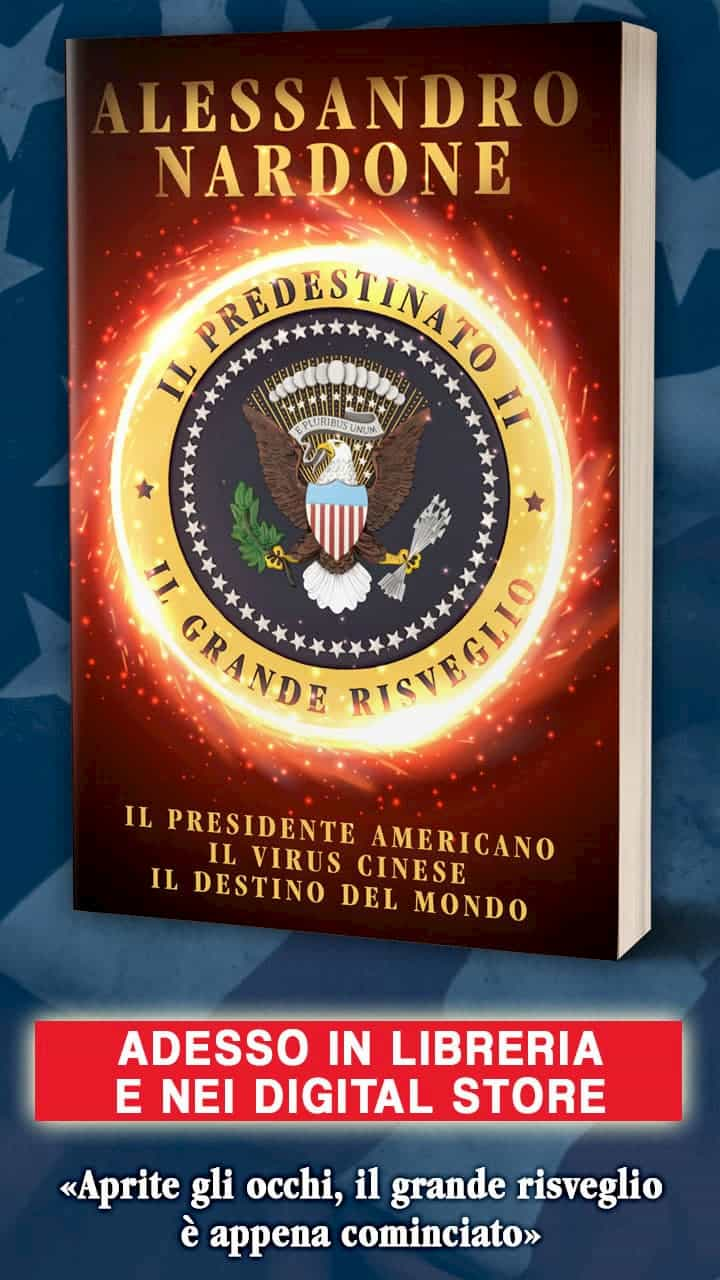Scriveva Franz Kafka tra le righe dei suoi “Diari” che «Le domande che non si rispondono da sé nel nascere non avranno mai risposta».
Ed è proprio la mancanza di una risposta, di un perché, a sviluppare quel senso d’impotenza – e profonda amarezza – che, da giorni, accompagna chi scrive.
D’altra parte, la lettura degli abusi descritti nelle carte della Procura di Piacenza commessi da alcuni (probabili) mascalzoni in divisa della caserma “Levante”, aggiunge alle parole dello scrittore boemo anche un retrogusto tristemente profetico.
Certo, sarà un processo in aula ad attribuire ai protagonisti coinvolti nello scandalo di Piacenza le eventuali responsabilità e sarà una corte ad emettere un verdetto.
Solo allora potremo avere la certezza della fondatezza delle accuse rivolte ai carabinieri arrestati e non certo adesso con questa gogna mediatica cui, da giorni, sono sottoposti grazie al lavoro degli organi di stampa, assetati di sensazionalismo più che di verità.
Una grancassa alimentata con l’inchiostro del disprezzo verso le divise che di bocca in bocca, ecciterà le vuote chiacchiere da spiaggia dei censori in costume da bagno, impegnati a occupare del tempo nell’attesa di un rinfrescante prosecchino serale.
Sentenze improvvisate, intrise di luoghi comuni, costruite su scricchiolanti fondamenta, la cui credibilità è supportata da fotografie (peraltro inutili ai fini dell’inchiesta), sottratte dai profili social dei “cattivi maestri” dell’Arma e sbattute in prima pagina, alla faccia della privacy tanto sbandierata dall’Ordine dei giornalisti.
Aperture corredate da ricche gallery in cui, spesso, sono immortalati anche i volti non oscurati di soggetti estranei all’indagine.
Che sarà mai? se gogna deve essere che almeno sia fatta con “professionalità”.
In fin dei conti, un buon processo mediatico (basterebbe guardare il documentario Netflix “Amanda Knox” per capire gli orrori commessi da un certo giornalismo) può incollare davanti alla tv, con il suo vantaggioso ritorno economico, milioni di telespettatori, oppure, catturare l’attenzione di lettori inebetiti dal caldo, sempre più avidi di notizie, anch’esse, però, pronte ad attizzare il fuoco degli abusi.
Prepotenze in questo caso giustificate a patto, come diceva Bari Weiss, che siano dirette contro i giusti bersagli.
Nulla di più ghiotto, infatti, quando a finire nell’occhio del ciclone sono proprio gli appartenenti alle forze dell’ordine colti in fallo (da rigore), i soggetti migliori contro cui sputare una massiccia dose di veleno.
Eppure, non svanisce quell’amaro in bocca, quel senso di delusione, di profonda tristezza nei confronti di chi, se le ipotesi di reato saranno confermate, ha disonorato, con azioni sconsiderate e violente, una divisa così piena di storia e di gloria.
E, proprio perché, da questo spazio, abbiamo sempre difeso le uniformi, ci sentiamo in dovere di condividere la riflessione di Piero Sansonetti quando ricorda che: «La forza di una democrazia sta anche nella civiltà delle forze dell’Ordine. Una polizia prepotente, o addirittura delinquente, è una ferita gravissima»[1].
Nulla deve essere nascosto, nulla deve essere taciuto. Troppi i capi d’accusa, e troppo gravi, per non fare quadrato intorno alla magistratura.
Tra tutti un capo d’accusa, quello di lesioni aggravate, è forse il più ignobile e detestabile per chi, quotidianamente, opera per garantire ordine e sicurezza. In un Paese, tra l’altro, ancora scosso dalle vicende legate ai casi di Stefano Cucchi e dello studente Federico Aldrovandi.
Tuttavia, non prenderemo mai parte alla gara della gogna più facile ed efficace, alla lapidazione mediatica intrisa del solito approccio ideologico fomentato dal livore dei soliti noti (sempre in servizio quando a richiederlo è il giustizialismo manettaro del “daje de gomito”).
Pratica che, è bene ricordarlo, ha ucciso il garantismo in questo Paese.
[1] Piero Sansonetti, “Carabinieri di Piacenza, linciati da giornali e procura senza un processo e possibilità di replica”, Il Riformista