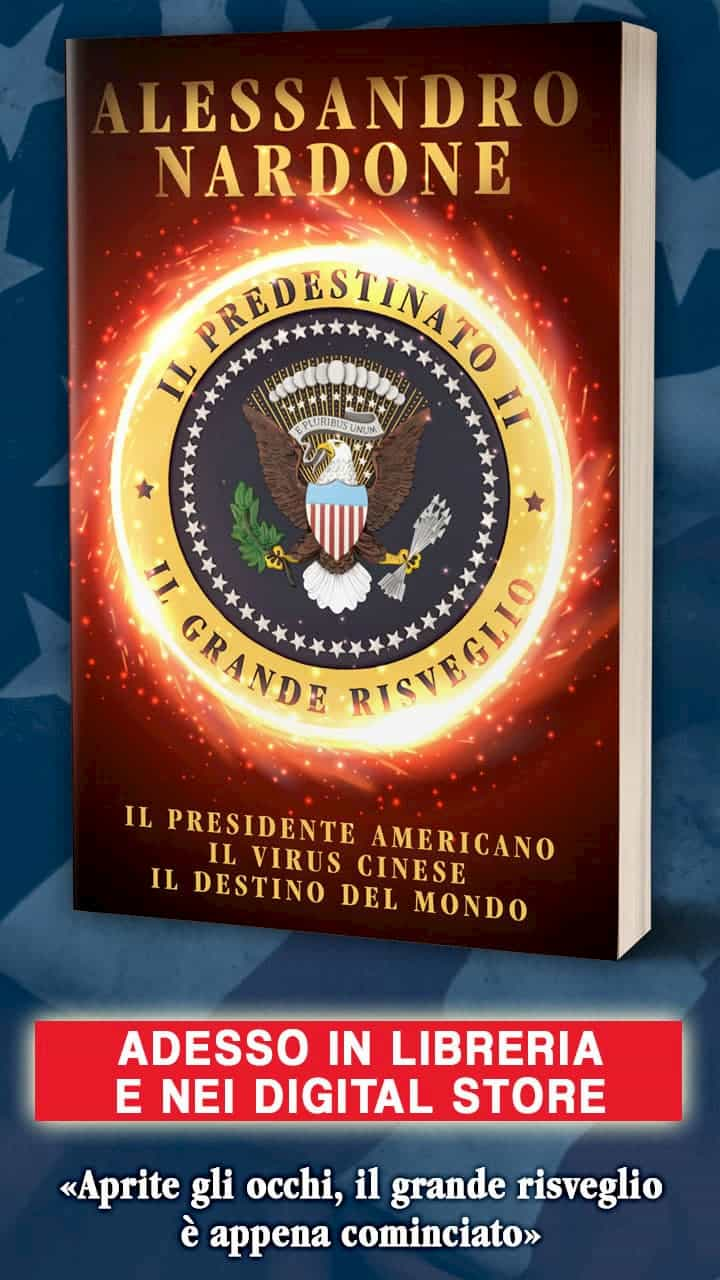In occasione del ventennale dell’11 settembre, ripropongo questo mio editoriale di due anni fa.
Buona lettura,
AN
Alzi la mano chi non rammenta dove si trovasse e cosa stesse facendo l’11 settembre del 2001, una giornata che per milioni di persone si staglia tra le reminiscenze più nitide di tutta una vita, anche 18 anni dopo. Constatazione per certi aspetti impressionante, soprattutto se consideriamo che il nostro cervello è ormai settato su una modalità di “accatastamento” dei ricordi, che giocoforza devono spartirsi lo spazio con i miliardi di input da cui siamo quotidianamente bombardati.
Eppure, allora la pervasività di Internet era lontana anni luce dai livelli che raggiunse dal 2007 in poi, con il lancio degli smartphone e la conseguente esplosione del fenomeno dei social network. Ergo, nel 2001 niente selfie, tweet, dirette su Facebook o storie su Instagram, ma aggiornamenti sui primi siti d’informazione online, email, dirette tv e – udite udite – messaggi sms.
È evidente come la compressione delle informazioni abbia portato con sé anche una sostanziale compressione del tempo: più fatti viviamo (direttamente o indirettamente), più informazioni assorbiamo e più la nostra percezione del tempo tende a dilatarsi. Ergo, 18 anni diventano un’era. Ma sono anche il periodo in cui è nata e cresciuta la Generazione Z, quella composta dai cosiddetti nativi digitali, che danno per scontata la connessione così come quelli della mia generazione facevano con l’elettricità e prim’ancora la generazione dei nostri genitori con l’acqua corrente.
Le ragazze e i ragazzi nati a cavallo dell’11 settembre 2001 sono stati la classica scintilla da cui è nata l’idea di impegnarci a realizzare uno speciale così importante sui tragici fatti di quel giorno e sulle enormi conseguenze che, oggettivamente, ebbero sul corso della storia. Perché un conto è raccontare ai giovani gli avvenimenti della prima metà del Novecento, e ben altro fargli vedere cosa accadde proprio mentre nascevano. Per intenderci, in questa fase della loro esistenza sarà più semplice che s’immedesimino in immagini provenienti da un mondo tutto sommato molto simile a quello di oggi, piuttosto che con i vecchi video in bianco e nero di ottant’anni fa.
È doveroso che sappiano, anzitutto perché ritengo sacrosanto non abbassare la guardia rispetto a ciò che l’11 settembre fu, ovvero un attacco ai pilastri sui quali si poggiano cultura, identità e stile di vita dell’intera civiltà occidentale, perpetrato inoculandoci un sentimento a cui non eravamo abituati: la paura.
Per ottenere questo risultato quale emblema migliore della più grande democrazia al mondo? Quale simbolo più efficace di New York, la città più famigliare anche per chi non c’è mai stato? Quale obiettivo più appropriato della nazione più potente dal punto di vista economico e politico? E ancora, quale preda migliore del paese più accogliente e insieme più patriottico di qualunque altro?
Nessuno, per il primo atto di quella che ancora oggi ci si vergogna a chiamare con il nome che le compete, ovvero Terza Guerra Mondiale. Un conflitto che gli integralisti islamici hanno scatenato con il preciso obiettivo di distruggere le certezze su cui si fonda il nostro approccio alla vita, che è a sua volta basato su un principio imprescindibile come la libertà.
Infatti, questo e gli altri attentati che si sono susseguiti nel corso degli anni, hanno in parte raggiunto il loro scopo, poiché, di fatto, hanno ridotto le nostre libertà individuali: basti pensare all’insieme di norme contenute nel Patriot Act, per arrivare a esempi più concreti come l’aumento delle misure di sicurezza negli aeroporti e all’ingresso di eventi e luoghi con grande richiamo di pubblico, o ai blocchi di cemento utilizzati per sbarrare gli ingressi a viali e piazze particolarmente frequentati.
Per carità, l’uomo si abitua a tutto, ma guai a lasciar passare il principio secondo cui dobbiamo assuefarci passivamente a qualsiasi cosa! Anche perché, il combinato disposto di casi come Nigergate e successivamente Datagate, conferma come qualcuno abbia deliberatamente sfruttato una causa giusta come la lotta al terrore per perseguire interessi di natura economica e politica.
Personalmente, da quel giorno in poi fui tra i tanti che s’impegnarono per fare in modo che il tragico ricordo di tutte quelle vittime innocenti non svanisse nel breve spazio di un articolo giornalistico o di un dibattito in un talk show televisivo, ma che si continuasse a scriverne, parlarne e discuterne per non perdere di vista il significato di quella tragica giornata. Manifestazioni, articoli e anche il mio ultimo romanzo, che inizia con un primo capitolo interamente ambientato a Manhattan l’11 settembre del 2001. Dopo quelle che riguardavano la morte di mio padre, fu certamente tra le righe per me più difficili da scrivere, tant’è che per riuscirci mi ci vollero mesi, nel corso dei quali feci una vera e propria full immersion di fatti, luoghi e persone.
Questo fece sì che il 15 novembre del 2016, fui ricevuto dalla 9/11 Memorial Foundation per consegnare loro alcune copie della versione inglese del libro. Circostanza che mi segnò molto perché, riconoscimento a parte, quando visitammo il Memoriale il mio sguardo si soffermò sul nome di Mario Nardone, una delle quasi 3mila vittime accertate. Ovvio, davanti a un elenco di quella portata (sia numerica che emotiva), andare a cercare il proprio cognome. Almeno, per me lo fu.
Una volta uscito, feci una ricerca in Internet e trovai alcune informazioni su Mario: aveva 32 anni, era di Staten Island e faceva il broker finanziario. Stando alle informazioni che reperii online era rimasta soltanto sua mamma, Linda, che peraltro lui aiutò molto dopo la morte del padre.
Allora decisi di mandarle una copia del romanzo, pensando che in qualche modo quella sorpresa avrebbe potuto farle piacere. Una volta rientrato in Italia infilai in una busta una copia del libro e l’appoggiai sulla mia scrivania: «Alla prima occasione lo spedirò», pensai, prima che finisse sepolto dagli impegni di una quotidianità sempre più pressante. Il 25 marzo, dovendo andare in posta a fare alcune spedizioni per gli Stati Uniti, presi quella busta e andai al computer per cercare l’indirizzo della madre: “Linda Nardone, Staten Island”, scrissi in Google, che di rimando m’impietrì.
Linda era morta il 6 marzo. Il libro rimase sulla mia scrivania e, insieme a lui, un’altra lezione su quanto sia vero, che ogni giorno dovrebbe essere vissuto come se fosse l’ultimo.