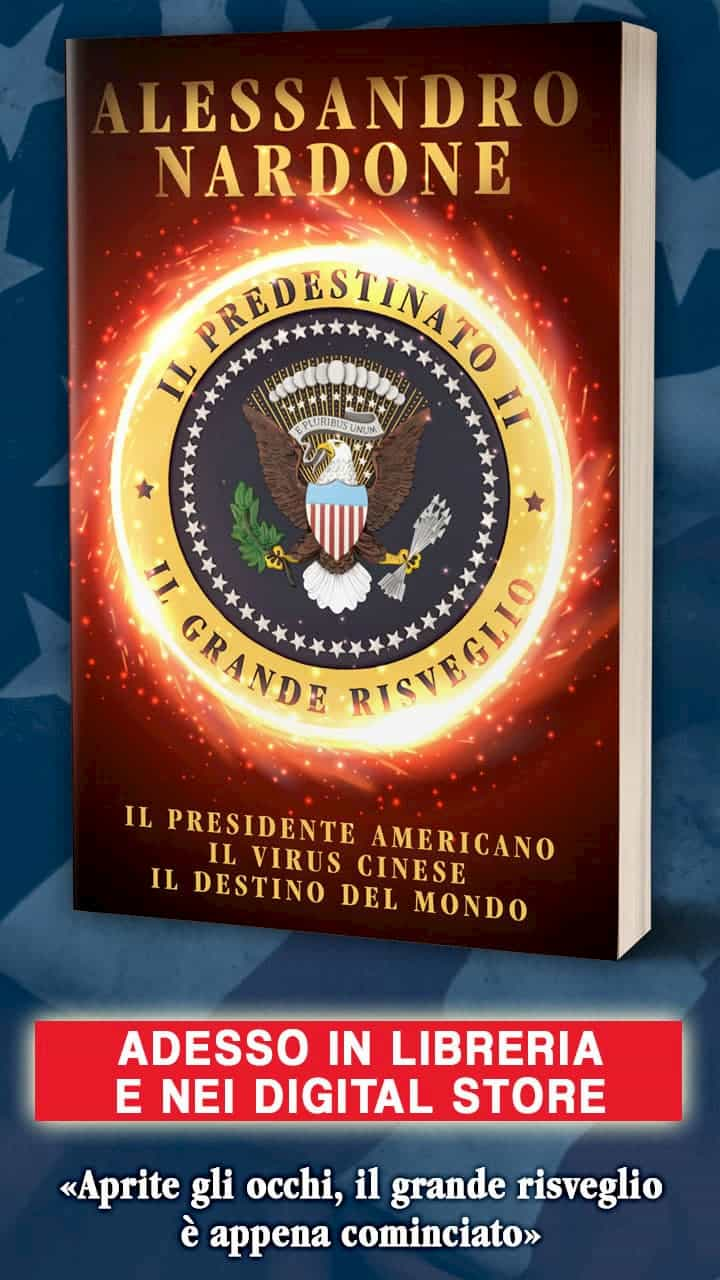Se c’è qualcosa che oggi riesce a fermarci mentre scorriamo distrattamente i social, è l’estetica in stile Ghibli. Quelle immagini hanno qualcosa di magico: trasformano la realtà in poesia, ci restituiscono la nostra umanità come se ce la stessero raccontando per la prima volta. Ma non stiamo parlando solo di nostalgia per i film di Miyazaki, e nemmeno di una semplice moda digitale. Parliamo di un fenomeno potente, che ci tocca perché ci mostra come siamo – e come vorremmo essere – in un mondo che spesso ci costringe a interpretare un personaggio anziché vivere una vita.
Lo ammetto, mi sono divertito anch’io. Ho “ghiblizzato” immagini di me stesso oggi e da ragazzo, quelle di mia figlia a cavallo, vecchie foto di famiglia degli anni ’80, un selfie dei giocatori del Como Nico Paz e Diao. Ho usato questa lente surreale per reinterpretare scene iconiche come quella di Rocky IV, con Stallone avvolto nella bandiera americana dopo aver battuto Ivan Drago, o la fuga in Honda di Verdone con Eleonora Giorgi in Borotalco. Anche momenti della storia politica di Giorgia Meloni. E poi, una foto di mio papà, che non c’è più.
In quel caso non era più solo un gioco grafico. Era un modo per toccare qualcosa che ci sfugge ogni giorno: il sentimento puro, l’emozione che non ha bisogno di parole, il ricordo che si fa presente attraverso un dettaglio disegnato con delicatezza. Non una ricostruzione fredda, ma una carezza. È lì che questa forma di intelligenza artificiale mostra tutta la sua forza: riesce a toccare le corde giuste, non con l’illusione, ma con la bellezza. Riesce a farci sentire qualcosa, e oggi non è poco.
Le immagini in stile Ghibli non ci chiedono di apparire, ma di esserci. Non servono filtri, pose, muscoli contratti. Serve solo la voglia di tornare a guardare il mondo con uno sguardo che non abbia paura della dolcezza. Ci liberano dalla tirannia della performance, ci permettono di abitare una versione alternativa di noi stessi, in cui la poesia vale più dell’efficienza. E questo, nel tempo dei like e dell’ansia da visibilità, è una piccola rivoluzione.
Funzionano anche per questo: perché non urlano. Sussurrano. E nel loro silenzio visivo, costruiscono connessioni. Scene personali, momenti pubblici, scatti sportivi o politici si trasformano in una narrazione collettiva che ci fa sentire meno soli. Perché anche nell’era dell’iperconnessione, abbiamo ancora bisogno di riconoscerci in qualcosa che vada oltre lo schermo.
Alla fine, il successo di queste immagini non è una moda passeggera. È un bisogno collettivo. Quello di vedere il mondo – e noi stessi – con uno sguardo più tenero, più profondo, più umano. Un invito a rallentare, a respirare, a ricordare. E forse anche a tornare, almeno per un attimo, a guardare la realtà con gli occhi di un bambino.