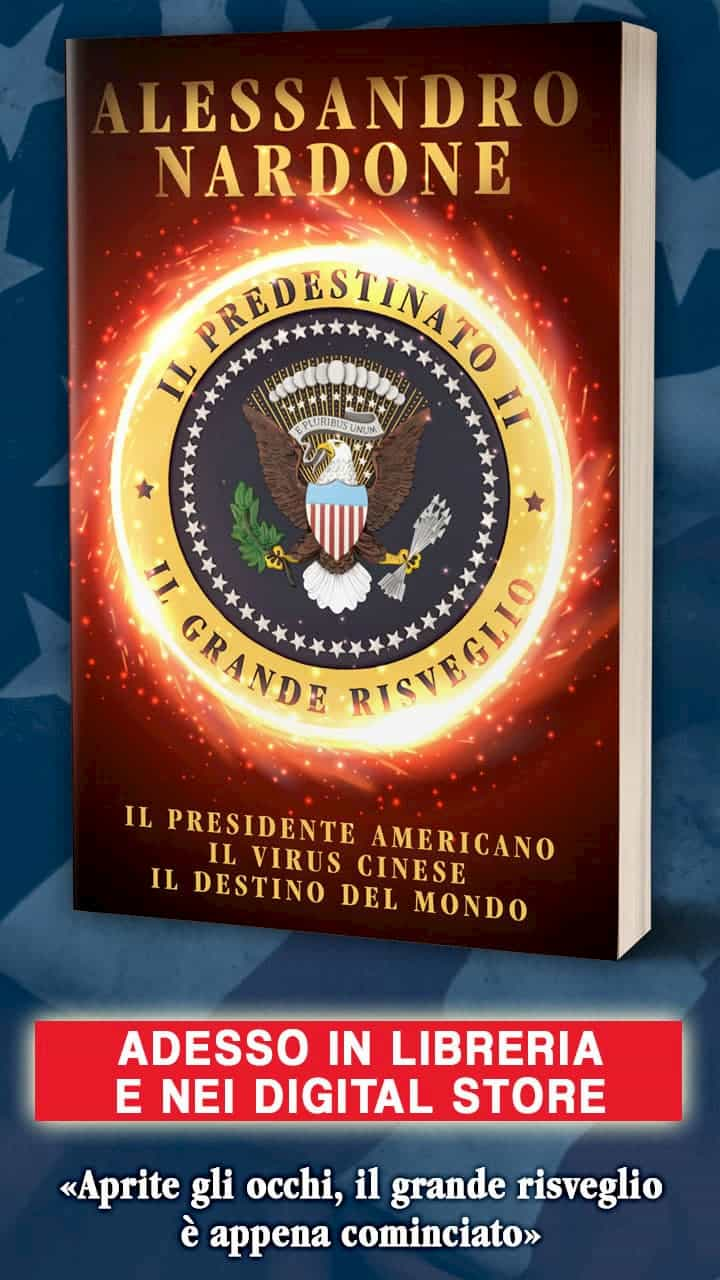Un anno esatto fa il mondo dell’informazione mainstream si leccava le ferite della ciclopica figura di palta rimediata grazie alla (per loro) inaspettata vittoria di Donald J. Trump. Nel corso della campagna elettorale non soltanto diedero per scontata la vittoria di Hillary Clinton, ma ebbero un ruolo attivo per far sì che la loro previsione si avverasse. A questo proposito è infatti bene ricordare che negli Stati Uniti il 95% dei media si schierò dalla parte dell’ex First Lady producendo, però, effetti diametralmente opposti rispetto a quelli auspicati, e cioè spingere l’elettorato tradizionalmente repubblicano tra le braccia di Trump e, al contempo, perdere quote ingentissime della credibilità conquistata in decenni di giornalismo se non super partes, quantomeno non palesemente schierato.
Un capolavoro vero e proprio, non c’è che dire. Certo, nei giorni immediatamente successivi al risultato qualcuno si è perfino illuso del fatto che questa clamorosa sberla fosse servita loro per “capire la lezione”, una sorta di ceffone educativo. Invece, a un anno esatto di distanza, ci troviamo ancora dinnanzi ad articolesse e servizi televisivi il cui unico fine è quello di disegnare un Trump dai contorni macchiettistici, focalizzando l’attenzione sui suoi eccessi verbali e abbassando volutamente i riflettori sui numeri da record registrati negli ultimi mesi dall’economia americana.
Insomma, reiterano gli errori del passato oltretutto passando per fessi, perché sembra che proprio non si rendano conto che il loro atteggiamento ostile è l’habitat perfetto per lo schema comunicativo di Trump: voi mi attaccate perché difendete gli interessi dell’establishment mentre io faccio quelli del popolo americano. Punto e a capo. Lo giudicate troppo banale per essere vero? Vi sbagliate, perché è esattamente questa la strategia che ha consentito al tycoon newyorkese di canalizzare i flussi di malcontento che ancora oggi pervadono gran parte dell’ormai ex middle class e di orientarli non su un partito – che di fatto non ha – ma sulla sua persona.
Attenzione, perché abbiamo sfiorato un altro passaggio importante, ovvero la centralità dei social nell’influenzare il risultato finale. Vero, sono stati fondamentali, ma attenzione a non cadere nel tranello di pensare che da soli abbiano potuto determinare il risultato in un senso o nell’altro: si tratta di strumenti fantastici per virilizzare un contenuto e diffonderlo a target mirati di utenti, ma in mancanza di contenuti efficaci il loro apporto vale zero.
Per meglio inquadrare il concetto pensate a un potentissimo megafono: strumento formidabile per amplificare le parole pronunciate da un oratore capace, perfettamente inutile (se non controproducente) se ad utilizzarlo è una persona affetta da balbuzie.
Questo per dire che il malcontento nei confronti dell’establishment è reale e si è diffuso ben prima dell’avvento di Trump che, da par suo, è stato bravissimo nell’intercettarlo, così come ha saputo sfruttare a suo vantaggio i numerosissimi scheletri nell’armadio (per loro non basterebbe un container) della famiglia Clinton. Imputare ai social il fatto che i democratici abbiano sbagliato candidato favorendo Trump è semplicemente ottuso, e illudersi che lo si possa abbattere con armi spuntate come il Russiagate o il gossip riporta alla mente la storia di un altro imprenditore “prestato” alla politica che, a 23 anni dalla sua discesa in campo, è ancora al tavolo a dare le carte.
Alessandro Nardone