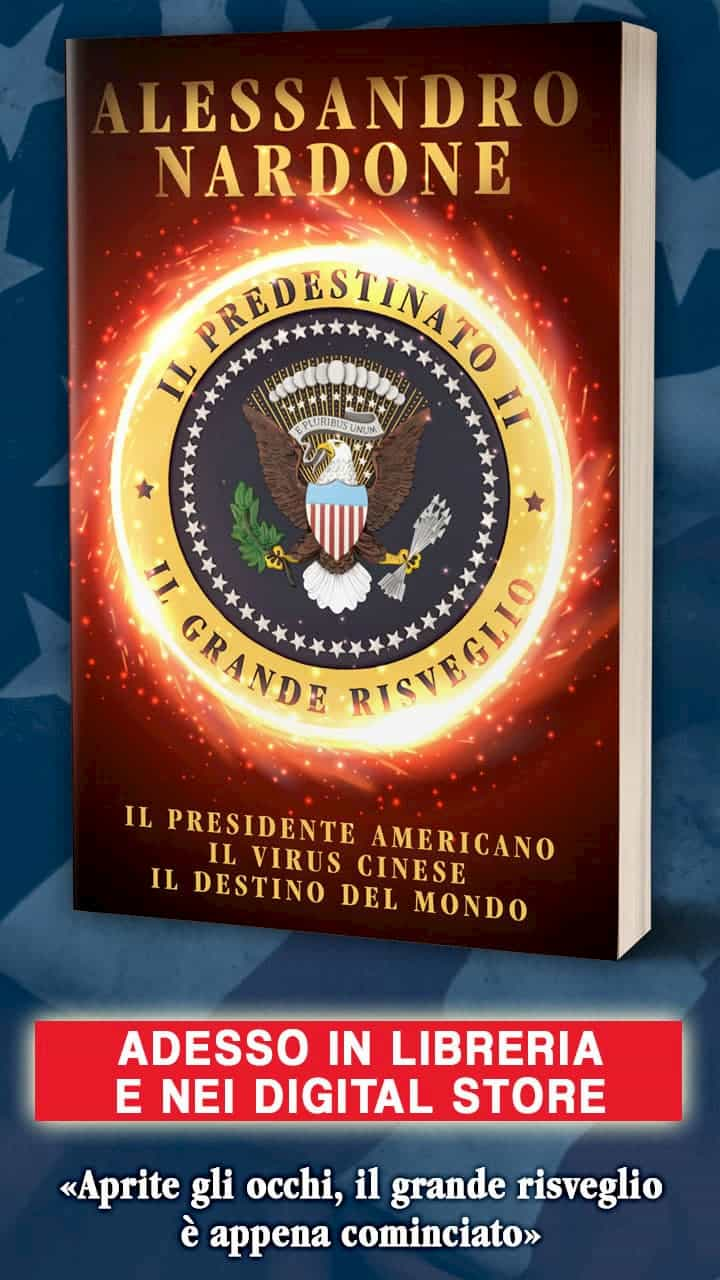Quante volte, leggendo riviste e giornali o ascoltando la TV, ci si è imbattuti nel termine “neoliberismo”?
La maggior parte delle volte, la quasi totalità a voler essere onesti, lo si è sentito in termini negativi, come un modello economico e sociale che, nella migliore delle ipotesi, abbia fallito o che abbia causato disastri e distorsioni a livello mondiale.
Bene, potrebbe non essere così!
Innanzitutto sarebbe opportuno comprendere di cosa si stia parlando.
Il “sentire comune” associa la parola allo stato minimo o assente, alle privatizzazioni “selvagge”, all’incuranza del welfare e della persona ma, ricorrendo a uno strumento come la Treccani, la definizione recita: “Indirizzo di pensiero economico che, in nome delle riconfermate premesse dell’economia classica, denuncia le sostanziali violazioni della concorrenza perpetrate da concentrazioni monopolistiche all’ombra del laissez faire e chiede pertanto misure atte a ripristinare la effettiva libertà di mercato e a garantire con ciò il rispetto anche delle libertà politiche. […]”
In pratica l’immagine che la vulgata propone non avrebbe nulla a che vedere con questo termine.
Andiamo per gradi, però.
L’economia classica citata rappresenta gli albori dello studio della materia, fin dall’epoca illuminista quando i primi fisiocratici cominciarono a interessarsi delle dinamiche del mercato ma il primo grande autore fu Adam Smith a fine ‘700.
Dalle sue intuizioni si iniziarono a sviluppare i temi fondanti di tutta la materia economica, dalla concorrenza alla teoria del valore con il suo celebre paradosso dell’acqua e dei diamanti, dall’importanza della libertà d’impresa e di scambio all’abbozzo della teoria dell’equilibrio economico sull’incontro di domanda e offerta che sarà, invece, formalizzata decenni dopo da Léon Walras.
Con David Ricardo iniziò lo studio più approfondito del valore e delle dinamiche di fissazione dei prezzi mentre, in seguito, con i marginalisti, Stanley Jevons, Léon Walras e Carl Menger, nacque lo studio del comportamento dei singoli, i concetti di utilità, lo studio delle dinamiche della domanda e dell’offerta e la ricerca dell’equilibrio di sistema che era visto, però, in un’ottica meccanicista (la famosa “mano invisibile”).
Questo breve e assai incompleto excursus serve a delineare le basi su cui si svolgerà, poi, tutto il dibattito che riguarda più la politica e il sentito comune degli intellettuali profani della materia economica verso quel “neoliberismo” che va a contrapporsi agli insegnamenti, solitamente, di John Maynard Keynes.
Keynes rappresentò un fortissimo punto di discontinuità nell’elaborazione dei modelli economici, introducendo dei concetti che, poi, entrarono prepotentemente in quella che, alcuni, chiamano la Teoria Dominante attuale che rappresenta un’elaborazione sincretica di tutti i contributi degli autori passati.
Non esiste, infatti, un modello neoliberista, almeno non è mai esistito nella realtà dei fatti, ma esiste un tentativo di “portare a terra” quei modelli che empiricamente sono stati giudicati funzionali alla crescita dell’intero pianeta e, di conto, alla diffusione del benessere tra gli esseri umani.
Quest’ultimo è un punto focale perché è il benessere diffuso che permette la crescita del sistema poiché questo è strutturato su una dinamica continua tra domanda e offerta e se non crescessero i redditi e non migliorassero le aspettative sul futuro della popolazione chi acquisterebbe prodotti e servizi al di fuori di quelli necessari alla sussistenza?
Ci torneremo sul punto.
Si parlava di discontinuità con l’opera di Keynes e, invero, il pensiero di questo autore eclettico ha influenzato il mondo, probabilmente, più di quanto egli stesso avrebbe potuto aspettarsi.
Oggi in tanti parlano del modello keynesiano come alternativo a quello di mercato e una visione distorta delle sue tesi è portata come vessillo da certe forze politiche ritenendolo, erroneamente, un alfiere dell’intervento dello stato in economia.
Nella fu mai così errato.
Keynes fu un conservatore, non un progressista, e fu, oltre che un abile uomo d’affari, uno degli strenui difensori del mercato come miglior allocatore di risorse e mezzo per ridurre le disuguaglianze nel mondo.
Il nodo del suo pensiero, spiegandolo con l’accetta, sta nella sfiducia nel sistema meccanicistico dell’equilibrio economico e nella negazione del principio della “mano invisibile”; in pratica sosteneva che il mondo si muovesse tra una crisi e l’altra e i momenti caratterizzati da un equilibrio temporaneo tra i fattori.
In questo contesto entra l’azione dello stato come stabilizzatore che dovrebbe attuare politiche espansive, anche a debito, nei periodi di crisi per sostenere la domanda aggregata e mantenere il sistema stabile.
Attenzione, però, che l’intervento dello stato non dovrebbe mai essere diretto a sussidi ed elargizioni una tantum ma dovrebbe dirigersi verso investimenti diretti (come quelli in infrastrutture) o indiretti (stimolando quelli privati) e da qui l’idea paradossale secondo cui sarebbe meglio pagare una persona per scavare buche e ricoprirle piuttosto che sussidiarlo per restare improduttivo.
Una volta riagguantata la crescita, però, le politiche espansive e l’intervento dello stato devono rientrare, per chiudere contabilmente le partite a debito attivate nel periodo precedente e scongiurare da un lato l’insostenibilità del debito pubblico e dall’altro il pericolo di inflazione.
Questa è la parte che gli strenui sedicenti keynesiani politici (o da chiacchiera) spesso ignorano.
L’etichetta di “neoliberista”, quindi, è oggi spesso affibbiata a chiunque critichi l’intervento eccessivo dello stato e si scosti dalla vulgata keynesiana che di Keynes, realmente, ha letto poco e male.
Ne parleremo…