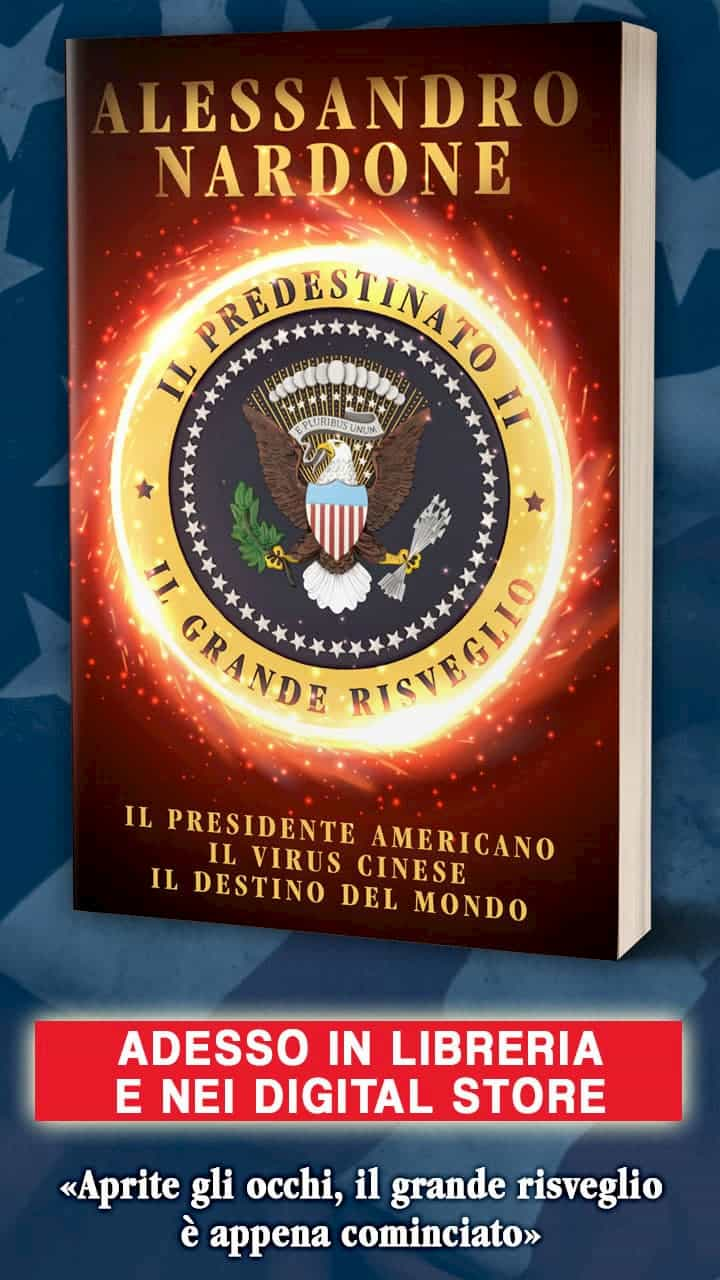Servirebbe forse un cartello di pericolo: «Attenzione, caduta statue». Perché se un monumento al giornalismo come Paolo Mieli sostiene che la censura preventiva adottata dagli anchorman americani nei confronti di Donald Trump è giusta, be’, allora siamo davvero tutti in grave pericolo. E forse possiamo anche chiudere baracca e burattini.
Nel suo editoriale sul Corriere della Sera, oggi Mieli scrive che la decisione di togliere la parola al presidente degli Stati Uniti è stata «impeccabile, perfetta, inappuntabile». Il motivo che avrebbe giustificato la decisione, da parte di più di un anchorman, è che il presidente si stava accingendo a denunciare «non provati brogli elettorali». Mieli aggiunge che la decisione è stata «corretta sotto il profilo deontologico» e addirittura «determinante per il disinnesco di un congegno che avrebbe potuto precipitare gli Stati Uniti nel baratro di una guerra civile».
Se questa è davvero la nuova linea prevalente nel giornalismo, il povero cronista trasecola e prova una sensazione più che sgradevole, terrorizzante: la sensazione che sia cominciato uno smottamento generalizzato verso lidi ancora inesplorati. Lidi pericolosissimi, illiberali, quasi «cinesizzati». Perché la censura, tanto più quella preventiva, quella che spegne l’audio, è inaccettabile, sbagliata, intollerabile. Lo è sempre, e nei confronti di chiunque.
Quando negli anni scorsi Osama bin Laden farneticava sul massacro dell’Occidente, lo si lasciava dire (giustamente!), perché per quanto alto fosse il rischio di un contagio tra i fanatici fondamentalisti, era comunque fondamentale che il pubblico sapesse che cosa passava per la mente del fondatore di al Qaeda, allora l’ideologo del terrorismo islamico. Chi voleva, poi, sui giornali in tv e per la strada, era perfettamente libero di criticarlo, di deriderlo, e perfino di giustificarlo.
Questo è l’Occidente liberale, questa è la democrazia, questo è il giornalismo libero. Il barbuto bin Laden, con le sue parole d’odio, creava pericoli decisamente molto superiori a quelli di una denuncia di potenziali brogli sulla bocca di un presidente sconfitto. Eppure nessuno si sognava di togliergli l’audio. Oggi, ed è davvero sconvolgente, lo si fa invece nei confronti di un capo di Stato democraticamente eletto, che pure denuncia un fatterello di qualche importanza, e cioè brogli elettorali sui quali peraltro dovrà presto pronunciarsi l’autorità giudiziaria. L’impressione è che questo accada, oggi, soltanto perché si tratta di un presidente ormai caduto nella polvere. Ed è un’impressione desolante.
Il caso Trump è molto diverso, ma riporta alla mente l’equivoca diatriba che a partire dal 1978, con il rapimento di Aldo Moro, accolse i comunicati delle Brigate Rosse (allora ancora ipocritamente definite «sedicenti», perché la grande stampa insinuava fossero in realtà terroristi neri dipinti di rosso). Eugenio Montale, sul Corriere, invitò a non pubblicare quei comunicati per «senso di responsabilità», perché così si faceva il gioco dei brigatisti. Alcuni giornali, e soprattutto l’Unità, allora potente organo del potentissimo Partito comunista italiano, decisero di non mettere in pagina nemmeno una parola di quei comunicati.
I radicali, che nei tempi peggiori sono quasi sempre un irrinunciabile faro di correttezza democratica, furono tra i pochi a battersi perché questo non avvenisse. Insieme ai socialisti e ai liberali.
L’oscurantista «obbligo morale» di un black-out sui comunicati dei terroristi tornò però a ripetersi nel 1981, con il rapimento del magistrato Giovanni D’Urso. Il 4 gennaio 1981 i brigatisti annunciarono che il loro ostaggio era stato condannato a morte, ma velenosamente aggiunsero che la sentenza era «sospesa»: D’Urso si sarebbe salvato se la stampa avesse pubblicato un proclama sottoscritto dal comitato di lotta del carcere di Trani. Sulla linea del No si schierò la maggioranza dei quotidiani italiani: Corriere, Repubblica, Tempo, Unità, Giornale… A pubblicare il comunicato furono solo Il Lavoro di Genova, l’Avanti del Partito socialista, Il Manifesto. Il Partito radicale permise a Lorena D’Urso, figlia del magistrato, di leggere in radio ampi stralci del comunicato. All’alba del 15 gennaio Giovanni D’Urso venne ritrovato vicino al ministero della Giustizia, in un’auto: era incatenato, ma vivo.
Fu una scelta giusta non soltanto per quel risultato, ma perché era del tutto incomprensibile e scorretta la decisione di privare il lettore del diritto di leggere una notizia, per quanto sgradevole ne fosse la fonte. Il lettore non è minorenne, né minorato: non deve essere protetto da un girello intellettuale, deciso in una redazione.
Per tornare a Trump, se oggi passa come fatto giusto (anzi, addirittura «impeccabile», come scrive Mieli) che un giornalista possa chiudere l’audio del presidente degli Stati Uniti soltanto perché gli pare stia affermando verità non condivisibili, allora il giornalismo diventa l’inevitabile vittima della faziosità di chi lo fa. E il risultato è drammatico: perché domattina il peggior giornalista di parte potrà legittimamente impancarsi a potenziale censore preventivo, assumendo un ruolo ancora più odioso di quello del censore governativo dei paesi dittatoriali.
Posso protestare, caro Mieli? Posso criticare il Corriere che sembra sostenerlo? Perché non è questo il lavoro che mi sono scelto, tanti anni fa. Soprattutto, non è questa la democrazia che per fortuna conosco: ma non voglio vederla cadere sotto l’impeccabile taglio d’audio di un giornalista antipatizzante, in nome di un malconcepito «superiore interesse». E spero di non essere il solo.