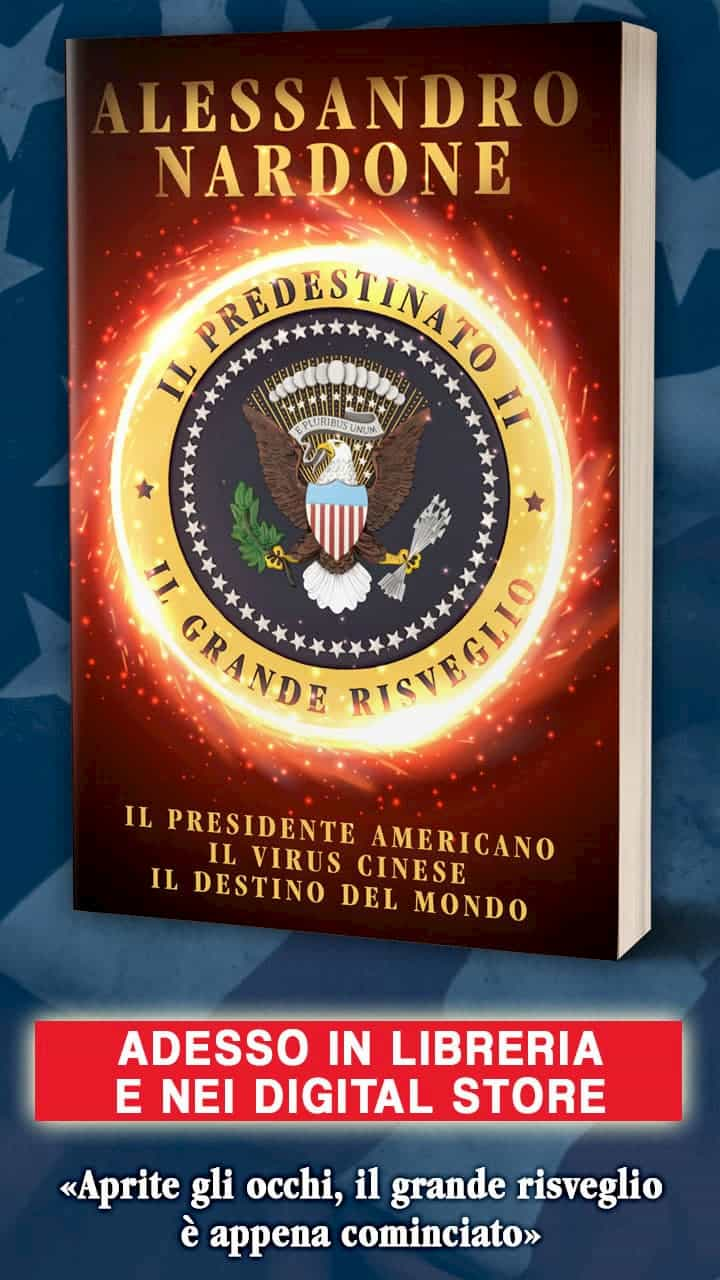Se da un lato l’editoria deve fare i conti con una costante emorragia di lettori (preoccupanti, alle nostre latitudini, i dati Ads, elaborati da Prima comunicazione in collaborazione con L’Ego 1), dall’altro, a puntellare il fascino frusto di una professione in catalessi, corre in soccorso il cinema.
Sarà forse merito del magnetismo impresso in alcune storie, sarà la contrapposizione tra “potere e controllore” spesso al centro delle sceneggiature più riuscite, sarà merito di alcune celebri battute capaci di attraversare le generazioni e fenderle come una lama calda nel burro, eppure il sodalizio tra cinema e giornalismo sembra non mostrare alcun segno di cedimento.
D’altra parte, la lotta tra bene e male, ma soprattutto la contrapposizione – non solo filosofica, ma principalmente etica – tra la libera stampa e l’ossessione generata dal potere (quello dipinto con i colori cupi del degrado e della prevaricazione), resta nel tempo l’irrinunciabile ingrediente con cui il cinema racconta la storia e preziose pagine di vita.
Storie che, al di là delle primitive logiche “parcheggiacervello” imposte, oggi più che mai, dal botteghino, hanno saputo coniugare l’impegno civile con l’intrattenimento, senza risparmiare, però, anche critiche feroci all’editoria e alla stampa.
È il caso, per esempio, di “Quarto potere”, pellicola preparata con cura e in pochi mesi da Orson Welles, che racconta l’inchiesta del giornalista Jerry Thompson, volta a scoprire il senso delle ultime parole del magnate Charles Foster Kane (personaggio ispirato alla figura di Randolph William Hearst).
Il film non è altro che un tortuoso percorso tra i gangli dell’amore e dell’odio, sviluppato attraverso le dickensiane interviste di Thompson. Colloqui che mettono in risalto i sentimenti contrastanti nei confronti di Kane.
Al principio del vero-falso, s’intuisce, ubbidisce l’intera struttura del film 2.
Tuttavia, in un’epoca – la nostra – costellata da tensioni sociali amplificate dall’utilizzo di fake news e dall’horror vacui generato dalla posteverità, sempre allegramente in bilico tra autenticità e finzione, il film di Welles (datato 1941) diventa un attualissimo attacco ai media, adulteratori di verità e creatori di falsi miti, ma anche un inquietante aforisma della storia recente del nostro paese, per esempio quando il ricchissimo Kane assurge a difensore delle istanze dei più deboli.
«Se non ci penso io a difendere gli interessi dei poveri – dice in un passaggio del film – ci sarà qualcun altro che lo farà, e magari sarà qualcuno privo di denaro e proprietà».
Se sulla partita del vero-falso è giocato l’intero impianto di “Quarto potere”, il film di Marco Bellocchio, “Sbatti il mostro in prima pagina”, utilizza uno strumento di finzione, il cinema, per raccontare, anche grazie alla scelta di avvalersi di materiale documentaristico, la temperatura ideologica e il grado di tensione sociale 3 attraversato dal paese nei primi anni Settanta.
Supportato dalla magistrale interpretazione di uno spietato Gian Maria Volonté, il film racconta il controverso scontro tra informazione e potere, un rapporto costruito sulla narrativa classica dell’archetipo dei film politici anni ‘70: la redazione di un quotidiano borghese filogovernativo e compiacente (“Il Giornale”, curiosamente lo stesso nome scelto da Indro Montanelli per la sua creatura più celebre, due anni dopo l’uscita del film), le zone d’ombra in cui spesso resta impigliata la verità, la notizia studiata a tavolino a uso e consumo di lettori intellettualmente penetrabili cui portare sempre “una parola pacata e definitiva”4. Un’ambigua lezione di giornalismo – quella di Volonté -, che si concretizza nel rimprovero al giovane collega, reo di aver confezionato un titolo sbagliato, unendo nella stessa frase le parole “disperato” e “disoccupato”, considerate dal direttore come una provocazione nei confronti di se stesso e dei lettori.
Bellocchio, dunque, disegna attraverso i personaggi del film (falsi eroi, assassini, guitti, giornalisti asserviti, ma anche reporter capaci e non addomesticabili), delle maschere.
Per dirla con Gianni Canova, pare di assistere, sì, a una rappresentazione deforme del potere, ma paradossalmente, anche dello spettatore.
Ciononostante, il cinema ha saputo dedicare anche grandi pagine al giornalismo d’inchiesta. La più celebre di tutte, probabilmente, l’ha firmata Alan J. Pakula (1976) con il suo “Tutti gli uomini del presidente”, dettagliato racconto dell’epica inchiesta condotta dai giornalisti del The Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein, impegnati a smascherare il complotto ordito nei confronti del Partito democratico.
Questa macchinazione darà il via allo scandalo “Watergate” e alle successive dimissioni del presidente Nixon.
Dello stesso anno anche il capolavoro di Sidney Lumet “Quinto potere”, un tragico e profetico atto d’accusa al mondo delle televisioni commerciali e alla deriva malata assunta dall’audience.
Al giornalismo d’inchiesta sono dedicati anche “Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio” (2003) e “Il caso Spotlight” (2015).
Se il primo titolo resta un toccante omaggio alla giornalista del The Sunday Indipendent uccisa per aver denunciato il traffico di droga a Dublino, il secondo ha il merito di mettere in luce, sul modello già collaudato da “Tutti gli uomini del presidente”, un meraviglioso affresco sul giornalismo-verità sordo alle pressioni del potere, anche quello più velato, ma non meno dispotico e monopolizzante, rappresentato dalla chiesa cattolica impegnata per anni a proteggere i suoi membri più indegni.
Un’ipocrisia illustrata, frame dopo frame, dalla febbrile dedizione con cui, una parte valorosa della redazione del The Boston Globe, smaschera reticenze e abusi sessuali compiuti da sacerdoti dell’Arcidiocesi della cattolicissima Boston.
Grazie al pragmatismo stilistico del regista Tom McCarthy, “Il caso Spotlight”, idealmente, si ricollega alla grande tradizione del cinema civile americano degli anni Settanta.
Ogni riflessione sul giornalismo s’allaccia, inevitabilmente, anche al rapporto ossessivo che spesso il cronista stringe con l’inchiesta. Una deriva emotiva, al limite del fanatismo, capace di annullare totalmente, nelle sue forme più estreme, ogni tipo di legame sociale.
È il caso, per esempio, del giovane vignettista del San Francisco Chronicle, Robert Graysmith – interpretato da Jake Gyllenhaal – il protagonista del film “Zodiac” diretto da David Fincher (2007).
“Zodiac” è un volo verso l’incompiuto; un prodotto che gioca sulle attese, esasperate quanto inconcludenti, ma anche capace di dipingere la realtà, spesso ai margini delle sceneggiature, in cui giornalisti in cerca di facili scoop si alternano sulla scena a detective troppo sanguigni per giungere con lucidità alla soluzione dell’indagine.
Sarà una coincidenza, ma la categoria umana del giornalista senza scrupoli trova nuovamente nella figura dell’attore Jake Gyllenhaal la sintesi perfetta tra ossessione, cinismo e il sensazionalismo prodotto da notizie granguignolesche da sacrificare sull’altare dei dati d’ascolto e del denaro.
D’altra parte il film “Nightcrawler – Lo sciacallo” (2014), non fa altro che specchiarsi nell’immagine, per nulla nobile e gloriosa, di una professione ormai priva di umanità, volta a vellicare gli istinti più beceri di un pubblico amorale.
A riportare al centro il tema della libertà di stampa e della protezione delle fonti 5, ha pensato Rod Lurie grazie a “Una sola verità” (2008).
Il film, non proprio un lungometraggio indimenticabile, consegna però al giudizio del pubblico un prodotto dal contenuto interessante.
Un’opera in cui il potere – ancora una volta rappresentato dal governo americano – trova nella giornalista Rachel Armstrong (Kate Beckinsale) un ostacolo cui mostrare il proprio aspetto più spietato, feroce e malvagio.
In fondo, è proprio il coraggio che esprime il personaggio, insofferente agli obblighi imposti dalle istituzioni, a far aumentare in chi osserva gli accenti celebrativi.
Dall’arbitrio che comporta il principio d’autorità, sembra ammonire Armstrong, ogni giornalista dovrebbe guardarsi per difendere, anche a costo dell’umiliazione più dura, il carcere, l’aspetto deontologico e morale insito nella professione.
Concludiamo il nostro sintetico viaggio tra cinema e giornalismo (all’appello, tra gli altri, mancano “The insider”, “Diritto di cronaca”, “Fortapasc”, “The Truth”, “Urla del silenzio”, “Good Night, and Good Luck”, “Il muro di gomma”, “L’ultima minaccia” e molti ancora), con uno dei pezzi pregiati griffati da Steven Spielberg: “The Post”.
“The Post” è un film dall’inconsueta potenza espressiva che introduce a una speculazione tutt’altro che affascinante: la censura della verità.
Nel mezzo scorrono figure tra loro diverse: per esempio Katharine Graham (Meryl Streep), l’incerto editore del Post che via-via acquista maggior coraggio e Benjamin Bradlee (Tom Hanks), l’impetuoso direttore alla perenne ricerca di notizie pubblicabili.
Al di là della cornice, la pellicola ha avuto il merito di portare in primo piano la vicenda dei “Pentagon Papers”, i documenti confidenziali che provavano le menzogne delle amministrazioni americane sulla Guerra in Vietnam. La pubblicazione del materiale top secret da parte del The New York Times e in seguito del The Washington Post, donò una vittoria insperata alla libera stampa e fu anche l’occasione per convincere l’opinione pubblica dell’inutilità della guerra.
Senza esibizionismi, il film serve allo spettatore un piatto succulento, condito da un giornalismo d’impronta civile che realizza la sua missione tra telefoni squillanti, carte da analizzare, riunioni infinite – splendide quelle telefoniche – e rotative che, solo attraverso il rumore, regalano il gusto della suspense.
“The Post”, va inteso, dunque, come una metafora, un inno, un gesto d’amore che unisce il cinema al mondo dell’informazione.
Note:
1 https://www.primaonline.it/2019/08/08/293199/classifiche-e-trend-dei-quotidiani-piu-diffusi-ads-giugno/
2 James Naremore, Orson Welles, ovvero la magia del cinema, Marsilio
3 Gian Piero Brunetta, “Cent’anni di cinema italiano”, Laterza
4 citazione tratta dal film “Sbatti il mostro in prima pagina”, di Marco Bellocchio.
5 Cfr. l’inchiesta dedicata a Wikileaks pubblicata su questa testata.