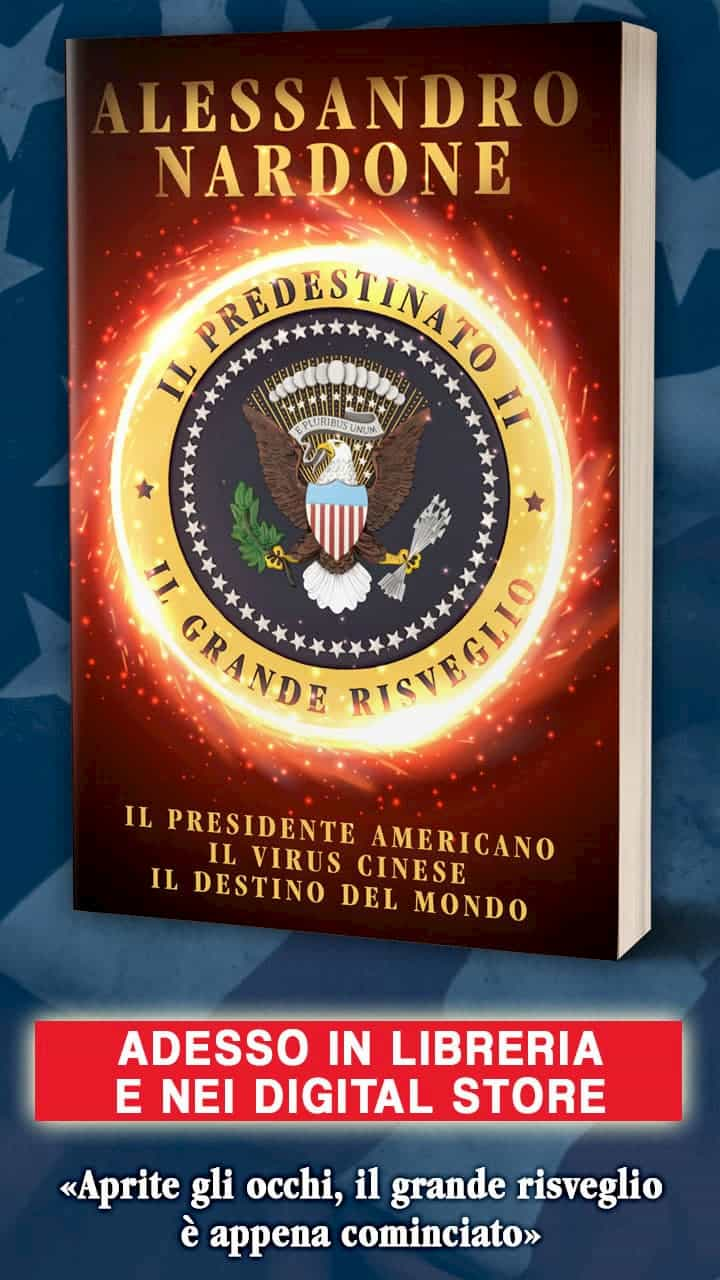Direttrice di Media Duemila (la prima rivista italiana di cultura digitale, fondata nel 1983) e vicepresidente dell’Osservatorio TuttiMedia, Maria Pia Rossignaud è una giornalista da sempre impegnata nella missione – tanto difficile quanto importante – di divulgare al grande pubblico analisi, studi, idee e riflessioni dei maggiori esperti del settore. Un’attività dal valore inestimabile la sua, soprattutto nell’ottica di fornire punti di riferimento a tanti addetti agli lavori che, complici i cambiamenti epocali portati dalla rivoluzione digitale, hanno la necessità di confrontarsi sull’impatto che queste nuove dinamiche hanno sull’intero sistema dell’informazione.
Ormai, scrivere un articolo giornalistico significa, spesso, dover trovare qualcosa che non solo possa essere interessante per il lettore, ma che abbia anche gli elementi giusti a livello di immagine (foto, video e audio) per poter diventare virale sui social: questo, a suo avviso, limita o esalta la capacità di scelta del giornalista?
Ogni media da sempre è caratterizzato da un linguaggio diverso (audio – video – scrittura). Quindi non vedo differenza fra ieri e oggi. La viralità è un elemento che ha, in effetti, poco a che fare con l’informazione, ma è piuttosto collegata alla capacità di far rimbalzare la notizia su più piattaforme e quindi farla arrivare ad un pubblico più vasto. Molti esperti del mondo della rete affermano anche che la viralità è effimera perché così come raggiunge picchi in tempi stretti, egualmente tonfa in basso senza più possibilità di rimonta.
Spesso si sente dire che Internet è il posto delle “fast-food news”, perché ormai gli utenti hanno poco tempo e leggono solo notizie brevi. Tuttavia, di recente, c’è chi si è inventato le “slow news” come alternativa a questo approccio. Lei da che parte sta?
L’elogio alla lentezza non è pensiero nuovo, solo recentemente Lamberto Maffei da presidente dell’Accademia dei Licei ha scritto un saggio sull’argomento. C’è un momento per l’aggiornamento veloce e un altro per l’approfondimento.
Come scriveva Walter Lippmann, le notizie formano una sorta di pseudo-ambiente, ma le nostre reazioni a tale ambiente non sono affatto pseudo-azioni, bensì azioni reali. È evidente che il fenomeno fake news vada ben oltre le classiche “bufale” e che prolifichi a seguito della ricerca spasmodica di “like” e di visualizzazioni. Secondo lei cosa manca ai media, e ai giornalisti più in generale, per riconquistare la credibilità perduta?
Lasciar perdere la corsa ai like (competere con i troll è complicato), ritornare ai fondamentali quali la qualità, l’umile ricerca di un dettaglio nascosto, il saper ascoltare sempre e chiunque, il racconto semplice che permettere alle persone di comprendere, di farsi idee e quindi agire su basi di un sapere condiviso e inclusivo.
Come detto, in Italia così come altrove, la popolarità professionale dei giornalisti (e della professione giornalistica) è ai minimi storici. Qual è, secondo lei, l’errore più grave che commettono gli operatori del settore?
Quella si sentirsi parte dell’olimpo degli dei. Il giornalismo embedded ha avuto la sua parte da leone in questa storia.
Al di là di quello che ritiene qualche politico ci pare evidente ormai, a livello globale, che il bipolarismo non sia più tra destra e sinistra, bensì tra élite di garantiti e popolo dei non rappresentati. A questo si aggiunge il paradosso tutto italiano di una democrazia orfana degli spazi in cui una classe dirigente possa nascere e crescere per formazione e non per cooptazione. Su quali basi e con quali strumenti (anche informativi) sarà possibile – secondo lei – costruire una nuova e autentica connessione tra popolo e classi dirigenti?
Il popolo dovrebbe essere anche classe dirigente, in una democrazia sana l’avvicendarsi dei ruoli crea empatia e connessione. Oggi le separazioni sono più forti delle unioni ed anche l’ignoranza, che dilaga in tutti i contesti, restituisce divisioni non inclusioni. La coscienza critica, quale materia da studiare a scuola, può essere un buon inizio, ma anche promuovere simulazioni di parlamenti e governi nelle scuole di ogni ordine e disciplina può essere un metodo che crea interesse connessione e attivismo civile.
Come accadde in passato con la televisione, oggi sono le esigenze del Web a controllare la nostra cultura e, in Internet, si vive o si muore di click, perché garantiscono potere e profitti della pubblicità. Esiste, secondo lei, un modo per superare il dualismo Google-Facebook?
Non dobbiamo superare nulla, nel senso che Google e Facebook fanno parte del mondo che da sempre si evolve. Pensiamo alle carrozze, alle macchine, al telefono, al rock, alla televisione, alla motocicletta. Ogni cambiamento è stato regolato. Ho letto su “Scientific American” che ogni novità tecnica o sociale di un tempo è stata considerata come disruption con ricadute negative sulle generazioni più giovani e sulla società. C’è bisogno di legislatori capaci di gestire la complessità dell’oggi senza demonizzare con l’obiettivo di costruire un equilibrio sostenibile.
Grazie a Snowden sappiamo che Orwell aveva ragione e che ogni singola azione che compiamo online viene intercettata, monitorata e catalogata. Questo significa controllo, che a sua volta è un sensazionale strumento di potere aumentato dalle “censure” imposte grazie ai luoghi comuni politicamente corretti. Quanto di questo “totalitarismo tecnologico”, ritiene che sia oggettivamente colpa di chi dovrebbe informare correttamente, ovvero dei giornalisti?
I giornalisti sembrano essere diventati il capro espiatorio di una società che non riesce a trovare i suoi fondamentali, avendo perso quelli su cui ha vissuto per secoli. La censura mi fa venire in mente i social credit che in Cina sono legge dal prossimo anno, un modo che permette alle autorità di delegare il controllo del territorio e delle azioni ai cittadini stessi. Un mondo in cui tutti spiano tutti e si sa tutto, McLuhan lo aveva predetto: «in futuro la metà del mondo spierà e riporterà sull’altra metà». Pratica che ricorda l’antico villaggio, la tribù. C’è sempre un po’ di passato nel nostro futuro, ai giornalisti va il dovere di tenere sempre alto il faro della conoscenza cosicché possa illuminare le menti della maggioranza.
Una delle suggestioni più frequenti tra gli addetti alla informazione è quella “robot journalism”, una definizione che viene associata all’uso di software in grado di realizzare testi di senso compiuto senza l’intervento dell’uomo. In prospettiva, lo vede più come un’opportunità o una minaccia?
Il modo dell’intelligenza artificiale è una risorsa se gestista con l’ottica dell’uomo al centro. Credo che stiamo andando inevitabilmente verso un sistema simbiotico di collaborazione uomo macchina, come è ben spiegato nel paper “Symbiotic Automous System” dell’IEEE e in particolare da Roberto Saracco (membro del consiglio) dell’associazione internazionale. L’uomo aumentato dalle sue protesi tecnologiche ne trae vantaggio se usandole bene riesce a fornire prodotti più chiari e completi. In strada un giornalista e un Ai che si imbattono in un morto riferiranno la notizia in maniera diversa. Immagino che l’AI dica: «cadavere di uomo bianco caucasico mezza età giace in via XXXX». Il giornalista immediatamente si immergerà nella ricerca di dettagli per costruire una storia… certamente la notizia intanto avrà fatto il giro del mondo ma la storia insegna che i dettagli fanno la differenza.
Secondo lei esiste una anche remota possibilità che il giornalismo – inteso come istituzione – possa scomparire per essere sostituito da un nuovo modo di trasmettere la conoscenza alle persone magari in maniera “meccanica”, o comunque con la definitiva affermazione del principio di induzione che attualmente gli algoritmi utilizzano per “selezionare” le notizie al posto nostro?
Gli algoritmi non selezionano le notizie al nostro posto, pongono alla nostra attenzione le notizie che sono più vicine o dello stesso ambito di quelle da noi scelte con maggior frequenza. L’algoritmo o l’intelligenza artificiale (come preferisco chiamarla) impara da noi. Alla fatidica domanda chi è la più bella del reame? Ognuno ha una risposta diversa e magari se dentro lo specchio della matrigna ci fosse stato un algoritmo Biancaneve avrebbe evitato tante traversie perché l’algoritmo avrebbe saputo che la risposta giusta oggi avrebbe risposte diverse a secondo di chi lo chiede.
Come leggeremo le notizie tra 5 anni?
Ovunque (anche il concetto di schermo così come lo intendiamo oggi sarà probabilmente superato). Il vero problema non è come leggeremo le notizie ma quali sceglieremo di approfondire e con chi.