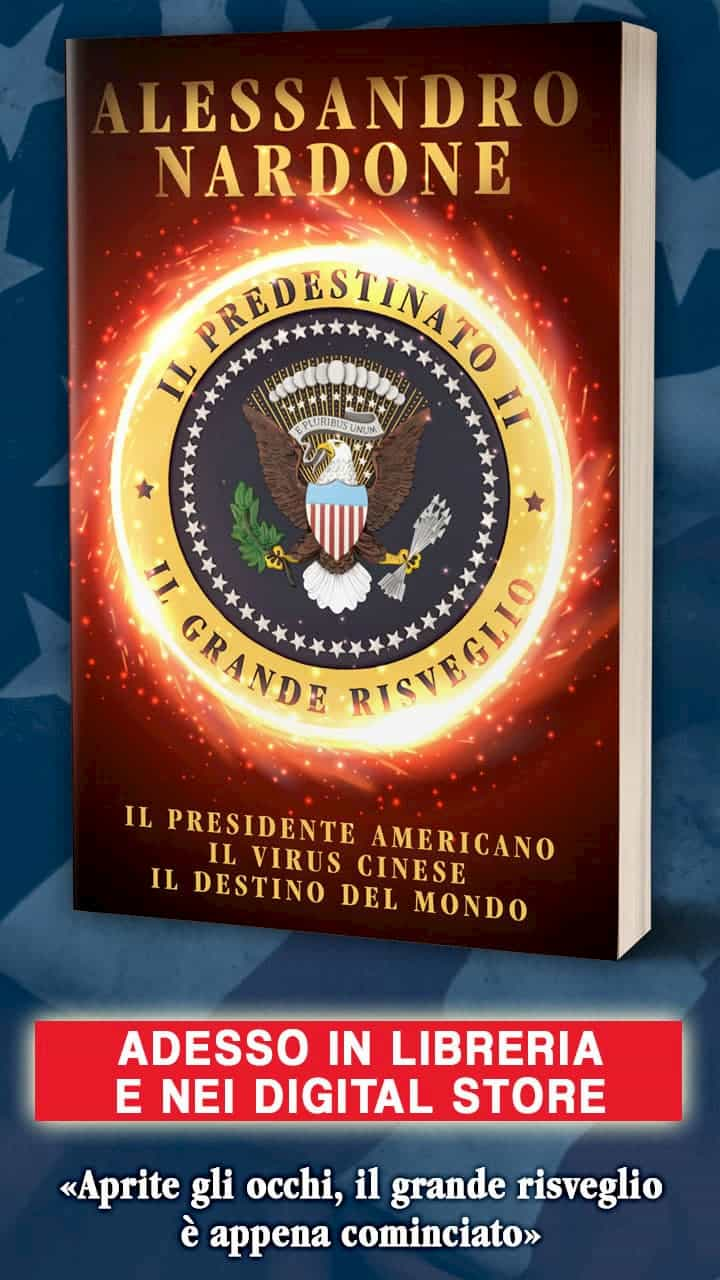«Questa scultura è la nostra voce, il nostro sostegno per il loro coraggio in difesa della verità. È il monumento di tutti, non di un credo politico o religioso, non di un paese solo, per questo motivo viaggia per le piazze del mondo».
Così l’artista Davide Dormino, friulano di nascita ma romano d’adozione, presenta ai lettori di Orwell l’opera “Anything to say?”, una scultura in bronzo con base in ferro (quasi una tonnellata di peso), che raffigura, posti in piedi sopra una sedia, Julian Assange, Chelsea Manning e Edward Snowden.
«Esempi – spiega Dormino – di rivoluzionari contemporanei, eroi controversi, soggetti amati e odiati ma comunque capaci di scardinare le regole di un sistema di controllo che gestisce le nostre vite».
L’opera itinerante, costata quasi 100mila euro (per buona parte raccolti grazie a un crowdfunding internazionale), ha già sostato in 13 capitali europee (Berlino, la prima, nel 2015 ndr) ed è pronta, a breve, ad affrontare un nuovo viaggio verso la “verità”, perché «Pretendere di sapere e informarsi non è solo un nostro diritto, ma un atto di resistenza per decidere in che mondo vogliamo vivere».
La sua opera “Anything to say?” (Qualcosa da dire? ndr) è dedicata a tre figure controverse, divisive e, in parte, poco sconosciute alle nostre latitudini: Julian Assange, Chelsea Manning e Edward Snowden. Perché?
«Il progetto nasce ufficialmente nel 2013 quando, incuriosito dal coraggio dimostrato da queste tre figure e, in particolar modo da Assange e dalla sua creatura Wikileaks, ho deciso di sviluppare un’opera in grado di far riflettere sulla necessità di difendere la libertà di parola e di espressione».
Un’opera, dunque, dal marcato valore civile?
«L’artista, ma potrei dire l’arte in genere, è il termometro del mondo.
Più precisamente, si tratta di un osservatore che racconta il proprio tempo attraverso il lavoro. “Anything to say?” amplifica questa convinzione anche allo scopo di cercare la “verità” da punti di vista alternativi, differenti».
Riassumendo, ha voluto “formalizzare” la sua battaglia a favore della libertà d’espressione?
«Esatto. In me è cresciuto il desiderio, l’urgenza di formalizzare, ha detto bene, la battaglia a favore della libertà di espressione».
Questo giornale, fin dalla nascita, supporta e sostiene le battaglie di Assange, Manning e Snowden. Nella scultura, immagino sia una scelta precisa, sono rappresentati in piedi. Può spiegarne il motivo?
«Le persone abili, capaci, coraggiose e anche generose, si fanno guardare mettendoci la faccia, senza sedersi mai. Si espongono».
In questo caso, poi, sono pure sopra una sedia. Sembra quasi un riferimento al londinese Speakers’ Corner…
«Stare in piedi sopra una sedia è considerato, dai più, un gesto irriverente, maleducato. Per me, invece, ha un significato opposto: “Ascoltateci, – suggerisce l’opera – guardate le cose da un altro punto di vista”. Lei ha ragione quando cita lo Speakers’ Corner, aggiungerei, però, come fonte d’ispirazione, anche l’illuminato professor Keating de “L’attimo fuggente”».
A differenza del monumento classico, “Anything to say?” è una scultura itinerante…
«Sì, perché volevo creare qualcosa di diverso, capace di muoversi per andare a cercare le persone. Un’opera cui, però, mancava un elemento…».
Quale?
«Il coinvolgimento del pubblico. La sedia vuota, infatti, rappresenta non solo un punto di domanda, ma anche la possibilità, per ogni cittadino che sentisse la necessità, di dire qualcosa attraverso un gesto semplice: salirci sopra».
Che tipo di reazione ha avuto il pubblico?
«Istintivamente di occupare la sedia libera. Un impulso, così almeno amo pensare, suggerito dalle altre tre voci “presenti”. La sedia non è altro che un piedistallo, uno strumento utile per uscire dalla nostra comfort zone che spesso porta all’indifferenza. La battaglia intrapresa da Assange, Manning e Snowden, è bene evidenziarlo con forza, riguarda tutti noi. Mi permetta di aggiungere una cosa…».
Prego.
«“Anything to say?” non vuole mettere in risalto solo il coraggio perché, nel rapporto col pubblico, può essere letta anche in altro modo».
Chiarisca, per favore.
«Per esempio, come a un’esecuzione pubblica. Provi a immaginare il numero di persone che ritengono i tre whistleblower (fischiatori, cioè informatori ndr) dei folli irresponsabili. Un’ampia fetta dell’opinione pubblica, soprattutto americana, ne chiede, quotidianamente, l’esecuzione con l’accusa di essere dei traditori. Quest’opera, pur dissociandomi da tanta brutalità, è stata pensata anche per loro. L’arte è libera, proprio come quella sedia vuota».
Lei, se non sbaglio, ha incontrato Assange nel novembre del 2014: è corretto?
«Sì, ho incontrato il fondatore di WikiLeaks presso i locali dell’ambasciata dell’Ecuador».
Può raccontarci quell’incontro?
«Impatto durissimo. L’ambasciata era presidiata da decine di agenti. Una volta entrato negli uffici mi privarono del telefono e del passaporto. L’appartamento era claustrofobico».
Mi scusi se la interrompo: ha saputo che un’azienda privata spagnola di security e intelligence, la Uc Global, spiava per conto della Cia ogni ospite di Assange?
«La conferma, ovviamente, l’ho avuta solo lo scorso autunno dagli organi di stampa, ma sono certo che lui, già al momento del nostro incontro, sospettasse qualcosa».
Cosa glielo fa pensare?
«Perché Assange mi disse «Stai attento: da questo momento, per un anno almeno, sarai sotto controllo». In molti considerano ancora oggi il fondatore di WikiLeaks come un paranoico (anche a causa della clausura forzata), invece, le recenti rivelazioni hanno rivelato che la sua intuizione era corretta».
Di cosa avete parlato?
«Abbiamo passato una lunga serata insieme. Con me erano presenti anche i giornalisti Charles Glass e Christophe Deloire, di Reporters Sans Frontières. Assange è una figura quasi mitologica: alto, con la pelle bianchissima. Sembrava davvero di essere al cospetto di una divinità. Ha parlato ininterrottamente: avevo di fronte uno scrigno contenente i segreti del mondo».
Ci racconti un aneddoto.
«Il lavoro era ormai concluso, stavo ultimando proprio i dettagli del viso di Assange. La base rotante su cui era appoggiata la scultura si blocca durante uno spostamento, l’opera si sbilancia, cede, e si distrugge completamente proprio sopra di me».
Immagino le imprecazioni. Peraltro, nemmeno particolarmente divertente come aneddoto.
«Non le nascondo una mia “esuberante” reazione. L’aneddoto divertente riguarda, invece, la battuta di Assange quando gli ho raccontato l’accaduto: “Ora hai sentito il peso di WikiLeaks”».
Provi a riassumere la sua opera in poche righe.
«La cultura crea coscienza. Questa scultura vuole essere una sorta di campanello d’allarme per ognuno di noi. In ballo c’è la libertà di stampa, la trasparenza, la conoscenza e, anche, il giornalismo d’inchiesta. Tutti capitoli che costituiscono il libro della nostra vita e non solo quella di Assange, Manning e Snowden. Essere informati ci suggerisce, inevitabilmente, dove vogliamo stare e soprattutto con chi. L’arte, in questo caso, è una straordinaria arma di difesa, molto più rapida della giustizia e della politica».
La sua opera, però, ha subito anche forti critiche perché Chelsea Manning è ritratta prima della sua lotta (vinta) per l’identità sessuale. Insomma, ancora nei panni di Bradley…
«Non vorrei riaprire questa polemica nata, soprattutto, sui social network. Alcuni non hanno apprezzato la mia scelta di rappresentare Chelsea Manning nei panni di un uomo nonostante il (successivo) cambio di sesso. Quando ho pensato l’opera, Chelsea era ancora Bradley…tutto qui. “Anything to say?” non è altro che un fermo immagine elaborato dalla mia mente, bloccato al 5 aprile del 2010. Spiace per le critiche ricevute, ma assumersi la responsabilità dei contenuti fa parte del percorso di un artista».
In un’intervista rilasciata alla rivista tedesca “Der Spiegel”, Assange ha dichiarato: «Mi piace aiutare le persone vulnerabili, mi piace fare a pezzi i bastardi». Traduciamo, semplificando, quel bastardi con potere/istituzioni. Eppure, proprio queste ultime, sgomitano vivacemente per mostrare “Anything to say?”. Non le sembra un paradosso?
«Assolutamente sì, eppure questo paradosso va inteso anche come un segnale positivo. Apprezzo quando l’arte è intesa come terreno d’incontro, insomma, come un ponte teso allo scopo di avvicinare istituzioni e cittadini».